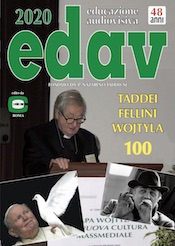STORIA E CINEMA: una vecchia questione da affrontare con strumenti nuovi
di LUIGI ZAFFAGNINI
Edav N: 366 - 2009
Un primo sguardo al problema.
Esaminare il rapporto tra storia e cinema non è certo una novità ma, in tempi di generale “emergenza educativa”, diviene di importanza strategica, sotto il profilo culturale, saper affrontare come il film tratta i temi storici e a come il pubblico li recepisce. Fino ad oggi, infatti, si sono occupati di questo i critici, gli addetti ai lavori e qualche docente che ha pensato di utilizzare il film come sussidio didattico.
La questione è invece molto più importante e, almeno per quanto riguarda l’Italia, investe il livello di consapevolezza e di memoria storica di un’intera società. Di più: si pone come uno degli aspetti decisivi in seno all’orientamento culturale e formativo tenuto da almeno mezzo secolo dalla editoria, dalla stampa, dalla scuola, dalla divulgazione televisiva e, in genere, da ogni agenzia e istituto che si siano proposti di diffondere contenuti di storia, soprattutto contemporanea, sul territorio.
Il problema presenta due livelli, che alla fine s’intrecciano: quello di coloro che, in varie forme, “hanno scritto di storia” o che hanno fatto dei film ambientati storicamente e quello di chi ritiene di aver appreso la storia dai testi o dai film.
I maestri del mondo classico distinguevano tra Annales (la registrazione cronologica dei fatti) e Historiae (la ricerca e quindi l’interpretazione storiografica)[1], ma ciò, al giorno d’oggi, non aiuta l’uomo della strada a comprendere la distanza che c’è tra la realtà degli eventi e la ricostruzione di essi attraverso il libro o il film, sia pure a partire da documenti.
Piuttosto, si può, senza troppo scandalo, accostare storiografi a romanzieri storici e a registi, per far comprendere che, un conto è vivere direttamente gli eventi, un altro scriverne narrativamente o saggisticamente, un altro ancora esprimere filmicamente una vicenda storica e un ultimo, infine, leggerne o vederne la rappresentazione filmica. Sono piani diversi che riguardano rispettivamente l’esistenzialità dell’uomo, la natura e la potenzialità di due diversi linguaggi, la consapevolezza che attraverso un’opera saggistica, narrativa o filmica si conosce non la realtà, bensì l’interpretazione di chi quell’opera ha prodotto.
Se a tanti fosse del tutto chiaro che un romanzo storico come I promessi sposi è più frutto di invenzione letteraria che non di corretta documentazione storica[2], non ci sarebbe bisogno di procedere oltre in questo discorso. Ma il fatto che, proprio tale romanzo abbia suggerito a generazioni di lettori lo scenario della storia della Milano del seicento, costringe a soffermarsi sul potere che ogni narrazione ha di invadere il campo della cultura storica. Appaiono in tal modo evidenti, sia l’impostazione storicista di tutta la cultura italiana, sia il fatto che gran parte della mentalità comune, in materia di conoscenze storiche, scaturisce da una scuola e da una divulgazione (compresa quella cinematografica), fondate su vicende storiche presentate in una particolare luce o su una storia celebrata retoricamente.
Per quanto, quindi, venga la tentazione di estendere al tipo di cultura italiana il duro giudizio popperiano sulla “miseria dello storicismo”,[3] basterà limitarsi a indagare come, da un lato, la manualistica e la critica storica si impongano ai lettori e come, dall’altro, la narrazione e la divulgazione filmica influiscono sul pubblico. D’altra parte, su questo tema risulta già sufficientemente chiaro, l’atteggiamento disincantato del poeta Eugenio Montale che afferma: “La storia non è prodotta / da chi la pensa e neppure / da chi l'ignora”[4].
Per Montale, infatti, la storia, cardine del significato progressista della “modernità”, anche se non può essere rifiutata come reale sequenza di eventi, può essere, però, oggetto di una critica demolitiva. Sottolineando, infatti, il carattere soggettivo delle ricostruzioni storiche, si sottrae alla storia in sé ogni possibile funzione celebrativa o di insegnamento moralistico.
Revisionismo: non è solo una questione di termini.
Scomodiamo, pertanto, una terminologia oggi sgradita, quale quella del Revisionismo storico. Tale formula viene utilizzata, da accademici e uomini dei media, per sconfessare ogni intervento o studio storico che affronti in modo non convenzionale argomenti quali la Rivoluzione francese o il Risorgimento, quali i Gulag del regime comunista o la Resistenza e tanti altri aspetti del passato o della contemporaneità. Parlare di Revisionismo come di un giudizio politico-culturale serve a far capire quella mentalità quasi generalizzata, in cui è egemone la cultura che, dal dopoguerra a oggi, l’ideologia di stampo marxista ha saputo creare. Questa, dopo aver allevato un’enorme schiera di intellettuali, li ha sistematicamente seminati, alla lunga di decenni, in tutti i livelli nella struttura dello Stato e in tutti gli ordini dell’apparato culturale e informativo. Lo schieramento ideologico marxista si è garantito, così, la fedeltà e il consenso di chi può diffondere una versione ideologica della cultura in ogni settore della vita sociale. Al confronto, la cultura di segno opposto, quella che, oggi, incute tanta paura a chi teme si voglia “riscrivere la storia”, si è ridotta a un ruolo di nicchia.
Storicamente tutto questo è avvenuto non per caso, ma non è questa la sede per indagare su un processo che riguarda nel suo intimo tutta la società italiana e il suo modo di pensare attraverso le varie stagioni politiche. Durante esse, infatti, si è praticamente realizzato il programma gramsciano di egemonia culturale[5].
A proposito, dunque, della disciplina storica, la stragrande maggioranza degli intellettuali ha effettuato un ferreo controllo egemonico e ha usato il linguaggio in funzione spregiativa contro quanti, accademici e non, hanno avvertito l’esigenza di una osservazione dei fenomeni storici con occhio non massificato. Per questo è stato adottato, con intento infamante, il termine Revisionismo, applicando all’uso di esso nel contestostorico quel significato che, nel dibattito politico interno al mondo socialista europeo di fine ottocento, designava i riformisti, non rivoluzionari e non massimalisti. Un termine adottato e codificato, poi, da Lenin e da Stalin per bollare come traditrice e opportunista la linea politica di quanti non nutrivano incrollabile fede nella rivoluzione, ma sposavano le idee del riformismo o della socialdemocrazia.[6]
Trasportato quindi dal mondo ideologico marxista a quello della indagine storica, il termine Revisionista mantiene, nelle intenzioni di chi lo usa, un fortissimo accento di disprezzo, che implica un giudizio inappellabile di tradimento della verità storica. Giudizio emesso da chi, ovviamente, si ritiene esclusivo possessore della verità medesima.
In ambito storiografico occidentale i primi a “beneficiare” dell’appellativo e del conseguente trattamento di Revisionisti sono stati storici dello stampo di François Furet, Ernst Nolte e Renzo De Felice. Non ci si può quindi sentire in spregevole compagnia quando si riafferma una vocazione revisionista, perché è insito nel metodo stesso della ricerca che l’indagine storiografica possa confermare, ma anche rivedere, correggere e aggiungere rispetto alle affermazioni di coloro che ci hanno preceduto. Se così non fosse, lo studio e la ricerca in questa disciplina non avrebbero senso. Sarebbero solo una presa d’atto di vicende e di documenti che si legittimano per l’impossibilità di discutere le interpretazioni di essi, elaborate da colui che per primo ne ha trattato o che è riuscito ad imporsi. La qual cosa è semplicemente un’assurdità, che costringerebbe la ricerca, non appena fatta, ad essere subito chiusa una volta e per sempre, con la prima stesura. Il termine Revisionista, non va rifiutato, dunque, perché colpevolizzante, ma piuttosto esibito come un titolo di merito, anche professionale, da chi avverte l’inesauribile tensione verso la compiutezza scientifica dell’indagine storica. Il vero storiografo, se non vuole limitarsi alla celebrazione, non può che essere Revisionista, nel senso di “critico”, proprio come Popper ha sempre inteso.
I nuovi strumenti concettuali e il problema del documento storico.
E’ pertanto nell’atteggiamento di base della ricerca culturale in generale e di quella storica in particolare che bisogna individuare la nuova prospettiva metodologica con cui accostarsi a vicende, argomenti, documenti. Lo strumento più idoneo, al momento, ci pare quello che si fonda sul fatto che, tanto la storiografia, quanto la divulgazione storica (sui libri o sui media dell’immagine) si comportano in base ai criteri della comunicazione intellettiva[7].
Ciò vuol dire che quelli che gli uomini si comunicano, sul piano intellettivo, sono aspetti qualitativi e immateriali, cioè le idee. Diviene, pertanto, quasi un obbligo discernere le idee che stanno dietro le affermazioni degli storici di professione e di chi narra o rappresenta vicende storiche e riflettere sul come e sul perché tali idee possano apparire arbitrarie, romanzesche, puramente congetturali, ideologiche o, al contrario, logicamente connesse e seriamente documentate.
E, in quest’ultimo caso, diviene un preciso dovere riuscire a far cogliere al lettore/spettatore il fatto che anche al cosiddetto “documento” non si deve concedere un’astratta fiducia, perché non gli si può affidare il valore di verità assoluta, da sovrapporre mimeticamente a una realtà, di cui né l’autore dell’opera, né tanto meno noi possiamo certo avere esperienza diretta. Anche un documento, per quanto paia un puntello solido e indiscutibile[8], è comunque un segno o un insieme di segni e non la realtà. Sul documento, infatti, influiscono anche l’esistenzialità di chi lo ha redatto e la funzione per la quale è stato redatto, così come su chi lo utilizza, a maggior ragione, gravano pesantemente le ipoteche della sua cultura, della sua capacità o meno di leggere il documento nella sua essenza, nonché il filtro della sua ideologia.
E se questi limiti valgono per il singolo documento, immaginiamo quanto essi debbano essere tenuti in conto da chi si serve della manualistica scolastica, sia come insegnante, sia come studente. E immaginiamo pure quanto uno spettatore di ogni film, ma soprattutto di quelli di ambientazione storica, dovrebbe vigilare per ricordare, a ogni inquadratura, che quella non è storia, ma espressione di un regista, che narra non di eventi, bensì di vicende individuali in contesti ambientali storicizzati soggettivamente.
Per non cadere, però, in un relativismo inutile, che finirebbe per negare un qualsiasi fondamento alla documentazione, il criterio procedurale più sensato è quello di individuare anche nel singolo documento o nella singola testimonianza le tracce dello svolgimento dell’intero fenomeno storico, chiedendoci sempre perchéci troviamo in presenza di certe affermazioni o di certi dati. Dobbiamo cioè sempre chiederci quanto queste affermazioni e questi dati dipendano da un riferimento a una possibile realtà e quanto portino di marchio dovuto alla esistenzialità, sia di chi ce li sottopone direttamente o mediatamente nel suo discorso, sia di chi, a suo tempo, ha redatto quel documento o rilasciato quella testimonianza.
Realtà, comunicazione e utilizzo del documento.
Appare quindi evidente che la realtà degli eventi non potrà mai essere conosciuta nel modo in cui si è oggettivamente verificata. Manca, infatti, umanamente, la possibilità di abbracciare con un solo sguardo spazio-temporale tutto l’evento, cogliendolo da ogni punto prospettico. Resta, invece, il conforto che la conoscenza storica, sostenuta da una corretta indagine ispirata al realismo comunicativo[9] permette di distinguere fino in fondo, nella narrazione degli eventi, tutti quegli apporti, che sono indubbiamente di natura soggettiva, dovuti all’autore, separandoli dalla traccia dei riferimenti alla realtà, che resterà pertanto innegabile.
Così facendo non si corre il rischio di ridurre gli eventi a un mosaico di aspetti da strumentalizzare separatamente a proprio piacimento, né di considerarli un continuum, cementato dalla invenzione o dall’interesse ideologico, là dove mancano ragionevoli motivi di collegamento.
Nell’affrontare la sua opera, lo storico, per via della sua esigenza di ricordare, descrivere, interpretare un evento con tutto il corredo di documenti che vi si richiamano, può imboccare due diverse strade. La prima è quella di considerare l’evento in sé come oggetto di studio per comprenderne l’essenza, la seconda è quella di attribuirgli un valore aggiunto di carattere strumentale in funzione della interpretazione che intende darne. In parole più semplici, una è la strada della lettura del fatto storico e dei documenti e l’altra è la strada della valutazione degli eventi subordinatamente a quella dei documenti. Tenere separati i due momenti non è così semplice come pare a prima vista. Un conto è capire cosa è accaduto in un certo periodo in un dato luogo e un’altro è vedere come è accaduto quel qualcosa e tutt’altro ancora è scoprire il perché è accaduto. Sono tre livelli diversi della ricerca sui fenomeni storici.
Ammettendo, con i limiti di cui sopra s’è detto, che sia davvero possibile conoscere con esattezza il cosa è accaduto nella sua precisa essenza, nel momento in cui si va a sondare il come, le possibilità di ricostruzione diventano sempre meno complete a causa della angolazione con la quale si è osservato il fenomeno (ad esempio quella dei vincitori o quella dei vinti). Quando poi si affronta la ricerca delle vere cause che hanno prodotto tanto il micro quanto il macro evento, diventa praticamente arduo risalire ad esse, non per quanto riguarda l’aspetto di causa immediatamente efficiente, ma per tutto quanto si riferisce alla esistenzialità umana che è sottesa da quell’evento.
Se si considera, infatti, il macro evento di una guerra, scomponibile in sotto-eventi di diversa natura, che vanno dalle battaglie alle complesse condizioni socio-economiche e spirituali che accompagnano uno stato di belligeranza, scomponibili a loro volta in una quasi infinita serie di micro eventi individuali, ci si trova in presenza di una sorta di piramide strutturale al vertice della quale sta l’incontestabile esito storico finale, ma collegato per sottili filamenti fino alla estesissima base delle reazioni, fin anche emotive, del singolo soldato e del singolo individuo coinvolto.
Quando interviene lo strumento del linguaggio.
Quando, poi, si deve tradurre tutto quanto si è conosciuto in una forma storiografica che faccia capire ad altri, a sua volta, il cosa, il come ed il perché, ci si imbatte nell’uso del linguaggio, che rende più difficile la testimonianza di ciò che si è conosciuto, a seconda delle scelte lessicali o di struttura del discorso che si adottano. Perché appare ormai chiaro che non si racconta né la Storia, né la realtà, bensì solo la propria conoscenza di quanto si è appreso dai documenti e da quanto si è collegato in un modo anziché in un altro. Questa conoscenza, che viene raccontata, non è altro che l’idea (interpretazione) dello storico circa i fatti reali, che ci sono sì stati, ma che non appartengono alla sua esperienza diretta, bensì che gli sono noti subordinatamente ai riferimenti documentali o alla narrazione che altri ne hanno fatto.
Ma per l’uomo comune, non addetto ai lavori, la conoscenza storica si riduce ben oltre a questo. Si riduce, a ben riflettere, a una memoria di micro-eventi personali, inserita in un inquadramento approssimativo, che altri gli hanno fornito, quasi sempre attraverso i manuali scolastici, attraverso la divulgazione e, soprattutto, attraverso i media dell’immagine.
Per questo ci sembra doveroso chiarire che quello che diventa influente nella percezione della dimensione storica della stragrande maggioranza delle persone non è certo lo studio personale della storiografia, bensì il fatto che tutte queste persone ritengono di essere venute a conoscenza di realtà storiche, mentre sono solo venute a contatto con le idee che via via storici, divulgatori, narratori, registi hanno loro comunicato. Per fare accettare a un pubblico tanto grande il principio che nessuna opera è di per sé autorevole testimonianza di storia, ma, nel migliore dei casi, una semplice mediatrice delle idee sugli eventi, occorre anche chiarire che queste idee possono essere di diverso tipo in base al livello di consapevolezza di colui che tratta i documenti, le testimonianze e i riferimenti agli eventi e in base all’obiettivo che egli si propone nei confronti del pubblico.
Prima di tutto e in ogni caso, chi si occupa di storia rientra, con tutti i limiti di cui sopra, nel novero di coloro che esprimono una qualche idea documentaria o perlomeno informativa degli eventi. In secondo luogo l’autore di storia può essere guidato da un’idea di tipo tematico, quando, parlando o scrivendo di un evento, intende servirsi di questo evento per introdurre attraverso la argomentazione una problematica che va oltre la descrizione del caso singolo di cui si sta occupando. O ancora può esprimere un’idea effettistica quando intende provocare qualunque tipo di emozione in coloro ai quali è destinato il suo lavoro, come non infrequentemente accade ancora oggi nei confronti di vicende e figure passate o recenti ricordate a scopo celebrativo e retorico,.
Limiti del concetto di verità storica.
Il concetto di verità storica, pilastro della modernità, va, quanto meno, filtrato con gli strumenti della scienza della comunicazione e testato con una metodologia orientata a un sano realismo.
Il lavoro del ricercatore storico, pertanto, anche se resta sempre qualcosa che ha a che fare con un attento controllo delle fonti e con la presenza di documenti, non può mai dirsi esaurientemente concluso. Un ricercatore potrebbe definirsi onestamente soddisfatto quando fosse certo di aver imboccato la strada per capire cosa è accaduto, come è accaduto e perché è accaduto. E se proprio dovesse appurare con compiutezza quello che è avvenuto, dovrebbe anche riconoscere che il lavoro che cerca di toccare gli altri due livelli è sempre obbligatoriamente approssimato nelle conclusioni, anche se non negli strumenti di indagine.
Giunti a questo punto va, allora, chiarito che il buon proposito tacitiano di raccontare la storia “sine ira et studio”[10] è solo una affermazione di principio, che può fare colpo su lettori sprovvisti di strumenti cognitivi in materia di antropologia e di scienza della comunicazione. Diviene, infatti, solo un tocco di civetteria da parte degli storici, quando non una velata ammissione di superbia, la pretesa di porsi al di sopra delle parti e di recitare un ruolo neutrale o imparziale in ossequio alla ricerca della cosiddetta “Verità Storica”. Si scorrano le opere degli storici e non se ne troverà uno solo che non affermi di “tifare” per “la” Storia, quando invece racconta, necessariamente, “una” storia. Necessariamente, sottolineiamo, non perché un autore sia deliberatamente votato alla mistificazione degli eventi, ma perché, anche quando si proponga di “dire di ciascuno senza amore e senza odio”[11], la sua ineliminabile esistenzialità e lo strumento del linguaggio di cui si serve per tradurre in segni comprensibili ad altri le sue idee e quanto intende riportare dei documenti e degli eventi, giocano un ruolo determinante, impossibile da ridurre a una registrazione asettica dei fatti. La neutralità del linguaggio in ambito comunicativo e soprattutto storiografico è, non solo una chimera, ma uno sproposito, destituito di qualsiasi scientificità. Basterà riflettere solo sulla opportunità che l’autore ha di optare per questo o quell’aggettivo, per questo o quel verbo, di mettere prima o dopo questa osservazione invece di quest’altra e si capirà che, anche quando questa scelta avviene senza malizia, l’esito che ne deriva è inevitabilmente marcato dalla individualità dello storico.
Agli storici, pertanto, si chiederebbe, non di essere quelli che, umanamente, non possono essere, ma solo di assumere consapevolezza della impronta personale che lasciano sul racconto degli eventi storici e di svelare tale impronta onestamente ai propri lettori.
Purtroppo, invece, l’obiettivo di molti ricercatori è solo quello di convincere che la propria interpretazione coincide con la realtà storica oggettiva e non accetterebbero mai di definire il risultato del loro lavoro come un’operazione pedagogica nei confronti dei lettori, il più delle volte solo funzionale alla loro ideologia.
D’altra parte questo ruolo degli intellettuali in genere, e degli storici in particolare, era già stato ben rilevato dallo studioso Tzvetan Todorov[12] quando ricordava che, negli anni in cui viveva nella sua patria d’origine, la Bulgaria, paese allora governato da un regime comunista, si chiedeva spesso come mai gli intellettuali occidentali non alzassero la voce per aiutare lui e i suoi compagni, cui veniva impedito il lavoro della libera ricerca. Trasferitosi, poi, in Francia nel 1963, Todorov si rese conto di quale fosse il modo di ragionare degli uomini di cultura del mondo occidentale che ammiravano fideisticamente le strutture politico-economiche nate dal marxismo-leninismo. Arrivò così alla conclusione che la Francia aveva un sistema democratico solo perché gli intellettuali erano pochi in confronto al resto della popolazione. Egli affermava, infatti: “Se in questo paese il voto fosse limitato agli intellettuali, oggi si vivrebbe in un regime totalitario”. Non è difficile pensare che un’affermazione del genere potrebbe essere considerata valida anche per l’Italia dal dopoguerra ad oggi e soprattutto per quella del dopo-sessantotto.
Non si va tanto lontano dal vero se si afferma che, troppo spesso, una certa animosità dottrinaria, conseguente alla mentalità ideologica, ha diffuso tra gli intellettuali un comportamento che ha fatto strumentalizzare gli eventi storici di ieri per colpire una volta di più l’avversario di oggi. Così facendo, però, essi non hanno tenuto conto del fatto che, anche qui in Italia, nasceva e si irrobustiva, pur nel silenzio e nell’ostilità di tanti ambienti accademici e ufficiali, una metodologia della ricerca culturale su base antropologica e comunicativa. Il punto di forza di tale metodologia risiede nel rifiuto di ogni funzione propagandistica e in un sistema concettuale teso ad evitare ogni possibile danno alla formazione della personalità individuale, causato dalla confusione tra realtà e segno, indotta dai linguaggi dei massmedia.
E’ stata proprio questa progressiva consapevolezza in coloro che hanno rifiutato la “sbornia” della politicizzazione forzata della cultura, che ha fatto balzare allo scoperto quanto Jean François Revel dice a proposito del modo di comportarsi di tutti gli storiografi ideologizzati, che si ritengono dispensati da obblighi intellettuali, pratici e morali. La dispensa consiste, secondo Revel, prima di tutto nel «riferire solo i fatti favorevoli alla tesi che si sostiene, inclusi quelli inventati totalmente e nel negare gli altri, ometterli, dimenticarli, impedire che siano conosciuti» [13].
Al contrario, presentare le proprie idee come tali e, al tempo stesso, offrire gli strumenti per valutarle insieme con le idee degli avversari, senza limitarsi a sconfessarle, è l’unico atteggiamento possibile di una visione etica del fare cultura secondo una prospettiva di servizio e non di potere.
Guardando al cinema.
Nel 1923, quando ancora Lenin era in vita e deteneva tutto il potere, non esisteva, in Unione Sovietica, la frattura che si sarebbe creata tra Stalin e Trotzkij. Questi, in pieno accordo con Lenin e con gli altri ideologi, scriveva sul potere del cinema e sulla importanza che esso aveva per l'ideologia comunista:«Il fatto che, fino ad ora, non abbiamo messo completamente le mani sul cinema, prova fino a che punto siamo inetti, incolti, per non dire stupidi. Il cinema è uno strumento che si impone da sè, il miglior strumento di propaganda [...] Il cinema deve essere un contrappeso all'attrazione dell'alcool, della religione...la sala cinematografica deve sostituire il bar e la chiesa, essere un supporto all'educazione delle masse».[14]Da quel momento, fino al 1991, il cinema sovietico insegnerà a tutte le cinematografie del mondo come si fa un film che trasmetta idee e ideologie. Il fascismo, prima, e il nazismo poi saranno i primi fedeli seguaci della scuola sovietica.
Si tratta di un aspetto che non appartiene solo alle cinematografie dei regimi totalitari, ma che riguarda ogni cinematografia, perché è dovuto alla specifica natura del medium cinema e alla struttura stessa del linguaggio delle immagini in movimento. E’ attraverso questo strumento (affiancato oggi da stampa, televisione, internet) che si concretizza gran parte della egemonia di un modo di pensare che trasforma i singoli individui in massa indistinta. Attraverso i canali della comunicazione di massa una qualsiasi concezione di vita finisce per assumere carattere di autorevolezza e come tale viene recepita. Il risultato più immediato di questa massificazione è quello di far sì che ogni individuo sia capace di riproporre all’infinito, in forme e contesti diversi, la stessa opinione che fa capo sempre al medesimo disegno ideologico. In tal modo quella opinione diventa di fatto un elemento portante di una mentalità che si diffonde e si radica. La particolare struttura del linguaggio, cui corrisponde una ben precisa forma di organizzazione del pensiero, favorisce la sudditanza, inibendo la facoltà di argomentare, cioè di “sostenere con argomenti”, vale a dire con prove e non con opinioni.
È da queste considerazioni che risalta una delle importanti novità del nuovo strumento con cui affrontare il rapporto storia-cinema e che riguarda tanto il film di fiction quanto il cosiddetto documentario. Individuando le “comunicazioni inavvertite” realmente presenti nella struttura dei messaggi (e non subliminali, cioè dipendenti da un fatto tecnico-percettivo), tale metodo insegna a leggerle fino in fondo e mostra come esse dipendano dalle scelte di chi ha fatto il film e non dalla realtà dei fatti. Con tale “lettura” si smaschera e si rende inoffensivo l’uso, come arma ideologica, di una comunicazione sottile o ingannevole. In questo modo si acquisisce, soprattutto, una forma mentis cognitiva, che permette, davanti a una vicenda filmica a sfondo storico o storico-documentaria, di non rimanere prigionieri degli aspetti emotivi, senza accorgersi che essi sono usati proprio in funzione di far passare una idea o meglio una concezione di vita, una tesi, che spesso è pura ideologia.
Per essere, pertanto, convincenti nei confronti di quel pubblico che è abituato da decenni ai contenuti interpretativi della storia presentata filmicamente e spettacolarmente con un linguaggio ideologico a senso unico, manipolato e che presenta una forte dipendenza dalla mentalità massmediale, occorre, prima di tutto, essere in grado di neutralizzare l’aspetto ingannevole, tipico del linguaggio utilizzato dai media. E’, infatti, sul potere di esso che fa affidamento lo schieramento ideologico dei comunicatori per riuscire a convincere che così è andata la storia.
Guardare, dunque, al cinema e alla storia contemporaneamente vuol dire, prima di tutto, leggere la struttura dei film nel profondo e l’organizzazione delle idee che lo sorreggono. Poi vuol dire utilizzare in chiave pedagogica e formativa l’esercizio di discernimento delle componenti del film negli aspetti della vicenda e del racconto. Individuare ciò che può essere riferito al piano storico e saperlo collocare al giusto livello di ricostruzione filologicamente corretta, distinguendolo da ciò che è indubitabilmente frutto di invenzione è un primo aspetto di ordine mentale che aiuta a prendere le distanze dal confondere realtà (storica) con rappresentazione (filmica). Ma questa buona logica di pensiero è la premessa per approfondire i concetti di storia e storiografia e di insegnamento di questa disciplina. Infatti, mentre un saggio o un manuale di storia si impongono al lettore per il principio di autorità, che si fonda sul nome dell’autore o sulla volontà di chi fa adottare il testo, il film, che si offre al pubblico indiscriminato, assume una autorità nuova e, per così dire, più penetrante nell’immaginario collettivo a confronto con qualsiasi lezione accademica. Non è certo un’esagerazione affermare che l’epica contemporanea, l’agiografia del mondo moderno, la retorica del sentimentalismo storico, la celebrazione della divisione manichea tra buoni e cattivi, ideologicamente connotati, tutto ciò trionfa nel cinema di ambientazione storica, sia esso d’autore o semplicemente artigianale. Ma, più di quanto accade in ogni opera letteraria, “mista di storia e d’invenzione”, secondo la nota definizione manzoniana, nel film sono le azioni, le parole, il sottofondo musicale, la recitazione, il taglio d’inquadratura e il montaggio a rendere plausibile e verosimile ciò che, quasi sicuramente, non è mai accaduto in quel modo e non è mai stato osservato con quell’angolazione o prospettiva. Nel mondo del film sono le vicende individuali dei protagonisti che costringono lo spettatore a inferire un giudizio sulla storia generale e collettiva, come se fossero testimoni di un’epoca. Questa forma di epica, nella tradizione culturale occidentale, è inusitata e imparagonabile a quella letteraria. Quanto meno, questa forma di epica è stata impossibile fino alla nascita del medium cinema. Da quando, infatti, la storia per immagini è stata servita a immense platee senza richiedere lo sforzo di uno studio individuale e critico, si sono affermate forme di pensiero culturalmente indifferenziate nei confronti della storia e il costume comportamentale si è pressoché globalizzato, a prescindere dalle forme di regime politico governanti i vari paesi.
Di fronte a questo orizzonte planetario si ferma il nostro approccio al confronto tra storia e cinema, ricordando al lettore attento, che, se ripercorrerà le sue esperienze di studente e di spettatore del cinema di un intero secolo, non potrà certo dimenticare i più svariati esempi di quanto abbiamo cercato di far rilevare con questa nuova rotta nel mare sempre affascinante della umana avventura della ricerca culturale.
[1] Sul significato di questi termini e sul perché anche l’impostazione della storiografia classica non sia utile a mettere a fuoco il senso di quanto in seguito diremo si vedano. G. Garbarino: Letteratura latina, Torino, Paravia, 1998, pagg. 903-914. Si veda inoltre M. Bettini, La letteratura Latina, Firenze, La Nuova Italia, 1995, vol. I, pagg. 413-416.
[2] Su questo aspetto suggeriamo: F. Nicolini, Arte e storia nei “Promessi Sposi”, Milano, Hoepli, 1939;; Id., Peste e untori nei Promessi Sposi e nella realtà storica, Bari, Laterza, 1937; Id., Una vittima storica di Alessandro Manzoni, Don Gonzalo Fernandez de Cordoba, Napoli, Pironti, 1946.
[3] K.R. Popper, Miseria dello storicismo, Milano, Feltrinelli, 2002.
[4] Cfr. E. Montale: Satura: La Storia, in Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 1984. “ La storia non si snoda / come una catena / di anelli ininterrotta. / In ogni caso / molti anelli non tengono. / La storia non contiene / il prima e il dopo, / nulla che in lei borbotti / a lento fuoco. / La storia non è prodotta / da chi la pensa e neppure / da chi l'ignora. La storia / non si fa strada, si ostina, / detesta il poco a poco, non procede / né recede, si sposta di binario / e la sua direzione / non è nell'orario. / La storia non giustifica / e non deplora, / la storia non è intrinseca / perché è fuori. / La storia non somministra carezze o colpi di frusta. / La storia non è magistra / di niente che ci riguardi. Accorgersene non serve / a farla più vera e più giusta. / La storia non è poi / la devastante ruspa che si dice. / Lascia sottopassaggi, cripte, buche / e nascondigli. C'è chi sopravvive. / La storia è anche benevola: distrugge quanto più può: se esagerasse, certo / sarebbe meglio, ma la storia è a corto / di notizie, non compie tutte le sue vendette. / La storia gratta il fondo / come una rete a strascico / con qualche strappo e più di un pesce sfugge. / Qualche volta s'incontra l'ectoplasma / d'uno scampato e non sembra particolarmente felice. / Ignora di essere fuori, nessuno glien'ha parlato. / Gli altri, nel sacco, si credono / più liberi di lui.”
[5] Sul concetto di egemonia culturale si veda una delle varie edizioni dei Quaderni di Antonio Gramsci in cui il fondatore del Partito comunista vede nelle potenzialità della cultura lo strumento per una educazione politica tesa alla conquista, alla gestione, al controllo del potere stesso. Scuole, università, redazioni giornalistiche, set cinematografici, studi discografici, associazioni culturali e del tempo libero: su tutto si estende un progetto egemonico della ideologia. Nella percezione gramsciana la cultura non esprime la realtà, ma la crea: i fatti non ispirano possibili teorie, ma sono le teorie a determinare i fatti. In tal modo l'intellettuale è ridotto - come afferma Gramsci stesso - al rango di «persuasore permanente».
[6] Cfr. Storia del Partito Comunista Bolscevico dell’URSS, Breve Corso redatto dalla Commissione incaricata dal Comitato centrale del PC(b) dell’URSS, Mosca, Edizioni in lingue estere, 1949. Passim e soprattutto pagg. 383-393.
[7] Si tratta di estendere a questa materia i criteri fondamentali della scuola di pensiero di Nazareno Taddei SJ (1920–2006), massmediologo, docente universitario e autore di numerose opere sul linguaggio dei media e sulla educazione all’uso delle tecnologie della comunicazione.
[8] Per comprendere appieno il senso di questa affermazione basta pensare a quanto siano poco attendibili sotto il profilo della testimonianza un documento fotografico o cinematografico o anche solo una informazione giornalistica, se non vengono sottoposti al rigoroso vaglio di una lettura semiologicamente fondata. Ma anche il documento d’epoca, manufatto o redatto da un uomo, porta con sé la medesima problematica, non solo relativa alla autenticità, bensì anche alla impronta esistenziale dell’autore.
[9] Con la formulazione “Realismo Comunicativo” intendiamo qualificare un orientamento del pensiero teoretico nell’ambito della scienza della comunicazione, del quale abbiamo trattato nei numeri di Edav 351, 361, 365.
[10] [Publio] Cornelio Tacito, storico del I secolo dopo Cristo, nel Proemio dei suoi Annales utilizzò questa formula, poi consacrata dal tempo, per dire che si proponeva di narrare le vicende senza avversione o simpatia (Cfr. Annales I,1)
[11] Cfr. [Publio] Cornelio Tacito: Historiae, I,1.
[12] T. Todorov, Memoria del male, tentazione del bene, Garzanti, 2001
[13] Revel J. F.: El conocimiento inùtil, Barcelona, Planeta, 1989, pag. 144.
[14] Marc Ferro, Cinema e storia, Milano, Feltrinelli, 1979, pag. 26.