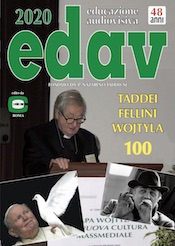NAZARENO TADDEI, UN GESUITA AVANTI - 5� Fellini
di ANDREA FAGIOLI
La fine della collaborazione televisiva è coincisa con la vicenda della «Dolce Vita»?
Quando ha conosciuto Federico Fellini?
Ho incontrato Fellini la prima volta sul set de «La strada», nel 1954, in aperta campagna romana. L’incontro lo aveva preparato Gian Luigi Rondi. Fellini stava per girare la scena dove Zampanò strappa via Gelsomina inginocchiata, piangente, davanti al Matto appena ucciso. Insomma, la scena dove Gelsomina impazzisce. Siamo arrivati durante una pausa e ci siamo messi a parlare. Eravamo tutti seduti in piacevole conversazione quando, al cenno del direttore delle luci venuto a dire che le luci erano pronte, la Masina chiese scusa e si appartò. Anche Anthony Quinn dopo un po’ la seguí. Fellini mi fece segno di lasciarli in pace: erano andati a concentrarsi sul posto della ripresa per prepararsi a girare la scena. Ricordo soprattutto la Masina, assorta, in ginocchio, con le mani sul volto: evidentemente cercava dentro di sé i sentimenti che il suo viso e il suo corpo avrebbero dovuto esprimere. Una dimostrazione di grande serietà professionale. La stessa che riscontrai in Fellini, anche in altre circostanze.
In quali, ad esempio?
Mi ricordo la volta che stava sonorizzando «Giulietta degli spiriti». Da ore cercava la musica per l’inizio, quando Giulietta appare nell’oscurità. Credo di essere stato con lui un paio d’ore. Cambiò un sacco di musiche. Ad un certo punto ne trovò una e disse: «Va bene questa». E venne a parlare con me. Quando il film uscí e andai a vederlo, mi accorsi che la musica iniziale non era piú quella. Il che significava che Fellini non era ancora contento nonostante il lavoro di molte ore. Questo, per ribadire la serietà di certe persone con una grossa fantasia, una grossa genialità, ma di una genialità che non è improvvisazione.
I film di Fellini sono diventati, uno per uno, un po’ il «cavallo di battaglia» delle sue «letture» e dei suoi corsi. Soprattutto «La strada», che lei ha sviscerato fotogramma per fotogramma e utilizzato nelle sue dispense ed anche nel recente volume «Dalla comunicazione alla lettura strutturale del film». Ricorda, oltre quel primo incontro, un episodio legato a Fellini e alla «Strada»?
Un episodio lo ricordo. Accadde una volta uscito il film quando pregai Fellini di venirlo a presentare nello Scolastico romano della Compagnia di Gesú. Venne e dopo la proiezione disse che lui non sapeva cosa dire, perché quello che aveva voluto dire l’aveva espresso con le immagini e passò la castagna a me. Io mi arrangiai a farne una «lettura», ricavandone l’«idea centrale»: «L’efficacia della bontà, anche al di là della morte, con una precisa ricaduta sulla terra, per una misteriosa solidarietà tra questo mondo e un altro mondo che non può non esistere al di sopra di questo». Fellini commentò che lui non avrebbe mai potuto dire a parole quello che io avevo detto, benché fosse proprio quello che lui aveva sentito dentro. Disse anzi che si commuoveva al pensiero d’avere espresso cose quasi inaccessibili, ma in maniera che chi leggeva il film le potesse comprendere.
Una bella soddisfazione.
Ma non è stata la sola: un’altra volta, dopo «Giulietta degli spiriti», m’è successo qualcosa di analogo. Un professore di una università giapponese m’aveva pregato di poter incontrare Fellini e, nel colloquio, gli chiese come mai non si preoccupasse di fare film in maniera che il loro contenuto cristiano potesse essere colto anche da culture differenti, come appunto quella giapponese. Fellini, per la verità, si arrampicò un po’ sugli specchi (da quell’impareggiabile bugiardone che era, per non dispiacere, anzi per far piacere all’interlocutore) e sembrava quasi stesse per dire che per lui, il suo film, era semplicemente una «favoletta», senza nessun riferimento alla religione, se non come ricordi o suggestioni d’infanzia. A quel punto, lo interruppi e dissi: «Ma la porta dove la metti?». «Quale porta?», mi chiese a sua volta sorpreso. «Federico – osservai io – il film l’hai fatto tu e che significato ha quella porta liberatrice che si apre quasi per un intervento esterno, mentre fino a quel momento è stata Giulietta nel suo animo esacerbato a vedere, immaginare e cercare di vincere tutte quelle cose angoscianti?». Fellini stette un attimo come soprappensiero, poi esclamò: «È vero! Ma è vero! Già, che cosa ci sta a fare? Io sentivo, sentivo…, ho sentito il bisogno di fare quello scatto quasi automatico della serratura, quasi risposta dall’alto all’angoscia di Giulietta».
Credo sia arrivato il momento di parlare della vicenda legata alla «Dolce vita», forse l’episodio che piú di altri ha segnato la sua carriera professionale e forse anche la sua vita. Dal 1960, per due anni, è stato in esilio a causa di una recensione «non gradita» del film di Fellini. Cosa ricorda dell’intera vicenda?
Innanzitutto, che quando il film fu presentato in anteprima al San Fedele di Milano, presente Fellini, io ero appena rientrato da 70 giorni di riprese in India per un documentario che doveva ricordare i 100 anni d’attività missionaria delle Suore di Maria Bambina. Il superiore mi disse che non potevo mancare alla proiezione nonostante che io cercassi di fargli capire che ero stanco. Dall’India, allora si tornava con gli aerei ad elica, non con i jet. Non so piú nemmeno quante ore di volo avessi fatto, piú il viaggio in treno da Roma. Mi pare che la proiezione fosse di pomeriggio e io ero arrivato a mezzogiorno. Il film, tra l’altro, sarebbe uscito il giorno dopo in una grande sala. Vidi comunque il film e lo trovai subito apprezzabile. Dopo la proiezione, mi ricordo che ci fu un piccolo rinfresco durante il quale Fellini, nonostante fosse circondato di gente, fece il possibile per avvicinarsi a me per chiedermi cosa ne pensavo. Io dissi: «Lasciami pensare un momento, perché è un film molto complesso. E poi sono stanco del viaggio e non me la sento di dare un giudizio, però mi pare una buona cosa». Nel presentare «La dolce vita», padre Favaro aveva parlato di un film con il «sigillo della porpora». Era la frase che padre Arpa aveva detto venendo da Genova dove aveva fatto vedere il film al cardinal Siri, il quale, grazie anche alle indicazioni dello stesso padre Arpa, lo aveva apprezzato. Cosa che invece non aveva fatto il cardinale Montini, che invece aveva raccolto le voci scandalizzate di alcuni suoi collaboratori, ma non aveva visto il film.
Può spiegare meglio questo contrasto tra due cardinali, di cui uno, di lí a poco, sarebbe diventato addirittura Papa?
Al San Fedele, le principali attività erano due: quella culturale legata a «Letture» e quella sociale con «Aggiornamenti sociali». Il settore sociale, si diceva, era gradito a Montini e non a Siri. Il settore culturale, viceversa, era gradito a Siri e non a Montini. Soprattutto dopo la proiezione della «Dolce vita», perché il presidente della Cariplo, che stava finanziando la costruzione delle nuove chiese nella diocesi di Milano e che era presenta alla nostra Prima di S. Fedele, andò a riferirne scandalizzato all’arcivescovo.
E dopo cosa successe?
I miei superiori mi diedero l’incarico di farne una «lettura» ponderata, oggettiva, per il nostro mensile «Letture», senza preoccuparmi delle voci di polemica che già da quella sera erano nate tra la posizione di Siri e quella di Montini. Rividi il film diverse volte e per ben dieci giorni e quasi dieci notti studiai la «lettura». Ne discutevo anche con lo stesso Fellini, il quale, per tutta quella prima settimana, mentre la folla faceva la ressa per andare a vedere il film, veniva da me ogni pomeriggio. Era addoloratissimo e umiliato, a volte piangeva….
Ce l’ho ancora quella poltrona dove Fellini per sei pomeriggi ha pianto.
E perché piangeva?
Perché la gente non capiva il suo film e soprattutto non lo capivano i cattolici. L’incomprensione dei cattolici ha chiuso la bocca a uno che poteva essere il cantore della Grazia. Con «La dolce vita», Fellini si era messo su questa strada: voleva parlare della spiritualità del cristianesimo. Ma rimase talmente turbato e amareggiato da quell’accoglienza che nel film successivo, «Otto e mezzo», film pagano all’acqua di rose, se la prese con la Chiesa ufficiale nella figura del Cardinale.
Cosa lo ha spinto a dire che «La dolce vita» trattava il tema della Grazia?
La «lettura» del film, esplicitata dalle immagini iniziali (con l’arrivo della statua di Cristo in elicottero) e finali quando il protagonista, Marcello, quasi ubriaco di stanchezza dopo una notte di bagordi, si trova con un gruppo di persone in riva al mare, e Paolina, la cameriera che aveva impressionato Marcello per la sua grazia innocente, si trova sorridente al di là di un piccolo braccio di mare a chiamarlo. Marcello la vede, ma non capisce e se ne va trascinato via da una delle donne del gruppo. Paolina continua a sorridere, come a dire: «Vai pure, al prossimo bivio mi troverai ancora lí ad aspettarti!». La «lettura» era evidente, ma mi sembrava difficile che Fellini avesse voluto esprimere un tema cosí… teologico. Nei nostri incontri del pomeriggio non si era mai parlato di «Grazia». Un giorno gli chiesi all'improvviso: «Cos’è secondo te la Grazia?». Mi rispose di botto: «Che cos’è la Grazia se non quella realtà, come Paolina, che tu non capisci e la rifiuti, ma lei sorride e ti dice: “Vai pure! Mi troverai sempre ad aspettarti”?». Risposta teologicamente perfetta, espressa però con linguaggio non da trattati teologici, ma a parole semplici, che sintetizzano il discorso che aveva fatto con immagini tutt’altro che devote. Per questo, forse, il film ha scatenato tante ire.
Comunque, lei aveva la conferma di aver «letto» giusto?
Certo, anche a distanza di oltre trent’anni e dopo aver studiato e ristudiato il film. Tuttavia, allora, sentendo l’aria infida, avevo chiesto ai superiori di dispensarmi dall’incarico dell’articolo per «Letture». Ma essi mi diedero l’ordine di «santa obbedienza», che come ho ricordato in precedenza è l’ordine piú solenne per un gesuita. Stesa la «lettura» chiesi ancora di non pubblicarla e mi arrivò un secondo ordine di «santa obbedienza», però si diede l’incarico a sette o nove gesuiti, di cui due venivano da fuori mentre gli altri erano del San Fedele, di rivedere con me il lavoro. Studiammo il testo parola per parola dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 8, con il solo intervallo del pranzo e senza il pisolino. Mi si chiese di cambiare solo un avverbio troppo forte e accettai perché non cambiava la sostanza. Tutti poi si assunsero la responsabilità del lavoro. Ma il padre Favaro insistette (non capii bene perché) che rimanesse la mia firma perché io ne avessi anche il merito.
Quando uscí la «lettura» della «Dolce vita»?
Quali furono le prime reazioni?
Pare, il disappunto del cardinale Montini. Certamente quello del Vaticano. L’«Osservatore Romano», a firma del direttore Della Torre, e «La Civiltà cattolica», a firma di padre Baragli (che pure si giustificò con me per iscritto, dichiarandomi suo maestro), mi attaccarono attribuendomi cose che non avevo né dette né fatte. Poco tempo dopo, il 19 maggio 1960, mi arrivò, sotto segreto del Santo Ufficio, l’ordine di partire la sera stessa in esilio «per avere disobbedito al cardinale Montini».
Chiese spiegazioni in proposito?
Sí, le chiesi direttamente al cardinale: gli domandai quando e come gli avessi disubbidito. Montini, preso alquanto di sorpresa, mi rispose che lui non mi aveva mai accusato di questo e mi fece capire una specie di promessa di interessarsi al mio caso. Comunque, poiché stavo finendo di montare e sonorizzare il citato documentario per le suore, di cui egli era anche il cardinale protettore, accettò che ritardassi di qualche giorno la mia partenza. Per finire il documentario, mi ricordo che mi misi alla moviola la domenica sera e mi alzai, escluso qualche momento per andare in bagno, neanche per mangiare, il venerdí alle 5 del pomeriggio. Poi, fatto il film, il giorno della festa io dovevo essere in esilio e quindi seguii la festa da un buco del loggione. Il cardinale Montini parlò molto bene del film, ma senza mai citarmi.
Una vera umiliazione, con in piú l’ordine di andarsene in esilio.
Il problema era che venivo castigato per avere obbedito: un gesuita che veniva castigato per avere rispettato la «santa obbedienza». Avrei potuto ricorrere, avrei potuto fare qualcosa. Il Signore mi concesse la grazia di accettare. Compresi che dovevo essere il capro espiatorio per salvare i miei confratelli del San Fedele e la faccia di due cardinali che non andavano d’accordo su queste cose. Chiesi allora ai miei superiori dove sarei dovuto andare in esilio. «Scegli tu dove vuoi andare», mi risposero. In quel periodo avevo «sulle spalle» due ragazzi, uno che doveva laurearsi e uno che voleva fare il tenore. Li mantenevo io a Milano, perché loro non avevano i mezzi, e li mantenevo con il mio lavoro in televisione. «Se vado in esilio – dissi – chi pensa a questi qua?». Chiesi ai superiori se ci avrebbero pensato loro. «No», mi risposero. «Allora, io rimango qui», dissi. «Noi non sappiamo niente», mi risposero.
Cosa vuol dire, che non è andato materialmente in esilio?
Ufficialmente sí, a Monaco di Baviera dove c’era la residenza della nostra rivista tedesca «Stimmen der Zeit» («Voci del tempo»). Ma in realtà, ci sono andato due volte per una decina di giorni e poi sono tornato per mantenere questi due ragazzi, che abitavano al San Fedele. Non mangiavo con gli altri, mangiavo dopo. E c’era qualche confratello che indispettito dal fatto che ero lí anziché in esilio, faceva il possibile per farmi mancare il mangiare. Tante volte ho saltato la cena. Nel frattempo, Fellini aveva chiesto di incontrare Montini. L’ho saputo dopo, dal regista stesso, non da altri. Il resoconto di quella visita, Fellini lo ha scritto in uno dei suoi libri. Dall’incontro ricavò un’impressione negativa. Praticamente fu ricevuto sulla porta.
Da questo si capisce che non c’era piú niente da fare: doveva accettare l’esilio, vero o falso che fosse.
Ai miei confratelli che s’erano assunti la responsabilità del mio studio e mi volevano difendere, arrivò l’ordine di non far sapere come stavano le cose, affinché si potesse «identificare la pecora nera». Me lo disse di persona, qualche tempo dopo, il cardinale Ottaviani, autore di quell’ordine, aggiungendo: «Quello è l’articolo di un gesuita, non di un cappuccino!». Il mio stesso padre generale, Janssens, mi disse che, pur non avendo io nessuna colpa se non quella di aver obbedito, nemmeno lui poteva intervenire in mio favore. E non poterono fare niente nemmeno i cardinali Samorè e Dell’Acqua. Il cardinale Samorè, tra l’altro, era originario del mio paese nativo, Bardi, ed era stato mantenuto in seminario da mio padre. Lo aveva curato come medico e poi lo aveva aiutato fino a che non era divenuto sacerdote. Quando mi arrivò l’ordine dell’esilio, mi rivolsi al cardinale Samorè, che mi accolse subito e mi disse: «Senta, lei vada in questo Paese dell’America Latina e si presenti a nome mio a questa persona». «Come faccio ad andare in America Latina? Chi mi paga il viaggio? E i due ragazzi?». Forse lui aveva già fatto il suo piano. Forse mi avrebbe pagato il viaggio. Ma si offese quando io gli dissi che avrei dovuto chiederlo ai miei superiori. «Io sono un cardinale», mi disse. «Purtroppo, senza chiedere ai superiori, soltanto il Papa può darmi un ordine». Andai anche dal cardinale Dell’Acqua, che mi disse: «Proprio ieri, sono venuti da me due signore della nobiltà nera. Mi hanno parlato contro il film e contro chi lo ha difeso con una tale arroganza che stavo per dire: “Quella è la porta”. Di conseguenza capisce qual è il mio pensiero circa il film di Fellini e quindi il mio pensiero sulla sua recensione. Però, io non posso fare niente, c’è di mezzo il cardinale Ottaviani e il Santo Ufficio». Dovetti insomma lasciare di colpo ogni mia attività, compresa la direzione delle trasmissioni religiose alla Rai. E nel modo che ho ricordato. A quel punto, però, mi mancavano i soldi per mantenere i due ragazzi. Allora cominciai a fare dei piccoli lavori, tramite degli amici. La fonte principale di guadagno divennero degli articoli pubblicitari per la rivista della Montedison, naturalmente firmati con altro nome.
Ma come, lei che aveva sempre messo in guardia dalla pubblicità, saltò dall’altra parte della barricata?
Mi dovevo arrangiare. Scrissi anche articoli pubblicitari per le calze da donna. Mi pagavano dalle 30 alle 40 mila lire per articolo.
Con un paio di articoli al mese riuscivo a vivere e a mantenere i due ragazzi.
Intanto, continuava a fare il «clandestino» a Milano.
Il direttore di «Letture» ricevette l’ordine, sempre segreto, di ritirare le copie del numero con la recensione della «Dolce vita» e di pubblicare una smentita della mia analisi del film. Ma per ben sei volte il testo venne respinto da Roma. Finalmente, in gran segreto, chiese a me di stenderla.
Non smentii un bel niente del contenuto. Mi limitai a sottolineare l’effetto inopportuno che quel mio lavoro avrebbe potuto avere su qualcuno (e ovviamente era vero). La «smentita», senza che si sapesse che era mia, passò. Fu pubblicato sul numero di luglio, sempre di «Letture», dello stesso 1960.
Intanto, devo ricordare che Giovanni XXIII, che senza conoscermi aveva apprezzato il documentario sulle Suore di Maria Bambina, informato della mia vicenda (cosí almeno mi si riferí segretamente), si disse dispiaciuto, ma che non gli sembrava il caso di opporsi al cardinale Ottaviani. Comunque, a parte questo, circa due anni dopo, informato da me stesso di come fossero andate le cose, il cardinale Ottaviani incaricò il mio padre generale di richiamarmi «ufficiosamente» dall’esilio. A questo proposito devo dire, anche se può sembrare strano, che la persona piú onesta in campo ecclesiastico che ho incontrato nella mia vita è stata proprio il cardinale Ottaviani: mi ha mandato in esilio senza sapere come erano andate le cose, ma quando ha saputo come erano andate, ha fatto di tutto per farmi tornare indietro e nel modo piú semplice possibile: «Il padre generale ti ha dato l’ordine di andare, il padre generale ti dia l’ordine di tornare».
Com’è che riuscí a spiegare al cardinale Ottaviani l’esatta dinamica della vicenda?
Nel periodo dell’esilio ebbi un incidente d’auto: venni investito da fermo, mi raccolsero con il cucchiaino e rimasi in coma per molto tempo. Dopo di che sono stato ingessato per quattro o cinque mesi da capo a piedi. Una cosa terribile. Non mi ero ancora rimesso completamente, quando decisi di andare a dire la Messa nella cappella dell’istituto di Rapallo dove mia sorella aveva cominciato la sua passione. Non sapevo nemmeno che il cardinal Ottaviani si trovava lí per le sue ferie. Durante la Messa, allora la si diceva rivolti verso l’altare con le spalle ai fedeli, sentii un passo zoppicante di qualcuno che entrava nella cappella. All’«Orate fratres» mi voltai e vidi che lí inginocchiato era proprio il cardinale Ottaviani. Finita la messa, una suora mi disse: «Sua Eminenza l’aspetta in giardino». Il cardinale mi disse che avevano dovuto mandarmi in esilio perché, come ricordato in precedenza, io ero un gesuita e non un cappuccino. Allora gli spiegai come erano andate realmente le cose e lui mi rispose di non averlo mai saputo. Alla fine mi disse: «Dica al suo padre generale che venga a trovarmi». Dopo due mesi il padre generale mi scrisse che potevo rientrare. Successivamente, ormai mi ero anche rimesso dall’incidente, andai a trovarlo personalmente e lui mi accolse a braccia aperte: mi ringraziò per aver fatto il capro espiatorio, mi disse che potevo riprendere il mio lavoro anche se non c’era nessun decreto che dicesse che io ero reintegrato. Ma dopo qualche tempo, il cardinale Ottaviani mi chiamò e mi disse: «Se lei si sente io vorrei che facesse questo certo lavoro». Era un incarico di fiducia che egli voleva affidarmi proprio per far capire che io dovevo essere reintegrato.
Non posso dirlo, è una questione troppo privata. Posso solo dire che si trattava di un’azione continuativa in un certo ambito. Comunque, gli risposi: «Eminenza, se permette, vado a chiederlo ai miei superiori». Andai dall’assistente d’Italia, che in queste cose era il mio diretto superiore, il quale mi disse: «Il cardinale Ottaviani l’ha mandata in esilio? Gli dica di no». Tornai dal cardinale e gli dissi: «Eminenza, i miei superiori non me lo permettono». Fra l’altro, a proposito di tutta questa vicenda, devo dire che è sempre stata coperta dal segreto del Santo Ufficio. Ad esempio, allora, non si è mai potuto dire che ero stato mandato in esilio a causa della «Dolce vita». Io stesso ero tenuto al segreto. E andare contro il segreto del Santo Ufficio è peccato mortale, a meno che non ci siano ragioni sufficientemente gravi, che in questi casi devono essere veramente gravi. Ho cominciato a parlare di questi fatti solo al momento che altri, autorizzati o meno, hanno cominciato a parlarne e in forme sempre piú o meno corrispondenti al vero. Mi sono ritenuto quindi obbligato in coscienza a cercare di ristabilire la verità, «data occasione».
Con Montini come andò a finire?
Una volta divenuto Papa, quando gli feci arrivare il mio grazie per aver visitato il mio padre generale Janssens morente (col quale aveva avuto qualche momento di difficoltà), mi fece rispondere con una bella lettera di saluto dal cardinale Dell’Acqua. Poi, interrogato dal mio nuovo padre generale Arrupe, disse che non aveva nulla contro di me, avendone anzi un buon ricordo.
E Fellini, di tutta questa vicenda, cosa le disse?
Un giorno mi disse «grazie». Mentre qualcuno mi chiese che cosa m’avesse mai dato Fellini perché avessi rischiato tanto per difenderlo. Ebbene, da Fellini, materialmente, non ho mai avuto nemmeno un caffè, tantomeno un invito a casa sua o al ristorante. Il nostro rapporto di sincera amicizia e di reciproca stima s’è sempre svolto nelle sedi di lavoro. Per parte mia, però, sono contento di aver dovuto soffrire qualcosa di non piccolo, anzitutto per avere obbedito e poi per difendere la verità nella sua opera. Cosa che invece non ha fatto chi ha accettato praticamente di rinunciare ad avere un cantore della Grazia. Infatti, dopo la delusione avuta dai cattolici per «La dolce vita» gli passò la voglia di trattare certi temi. Fu Fellini stesso a dirmelo e ne ebbi conferma nei film successivi. Ad esempio, dopo la «Dolce vita» Fellini mi parlò di una piccola suora d’un manicomio giudiziario che sentiva come possibile personaggio per sviluppare il discorso della Grazia accennato con Paolina. Ebbene, quella piccola suora l’ho rivista in «Amarcord», ma era tutt’altra cosa: era come depauperata di tutta quella dimensione spirituale nella quale l’aveva vista allora.
A proposito dell’opera di Fellini, è fuori discussione il contributo dato dagli attori. Lei ha già ricordato la serietà professionale della Masina e di Anthony Quinn. Ma c’è un attore che piú di ogni altro ha segnato il cinema di Fellini, a partire proprio dalla «Dolce vita»….
Appunto. Che ricordo ha di Mastroianni?
Di persona l’ho appena incontrato qualche volta di sfuggita. Ma è stato un personaggio straordinario: se non l’ultimo, certamente uno degli ultimi grandi attori. Mastroianni ebbe due importanti punti di riferimento: Visconti e Fellini, pur avendo fatto numerosi film interessanti e importanti anche senza di loro. Ma certo con Fellini ha fatto grandi cose: basterebbe pensare anche soltanto a «Ginger e Fred» dove forní, insieme all’indimenticabile Giulietta Masina, una prova veramente stupefacente. In quel caso non era l’attore, era l’uomo ad essere diventato Fred Astaire, cosí com’era successo per il protagonista della «Dolce vita» e di «Otto e mezzo». Mastroianni, poi, non era un poltrone come teneva a far credere. Aveva la testa sul collo, era puntuale come un orologio, lavorava come un matto e aveva una memoria di ferro. Gli piaceva però mostrarsi scettico e lento, ma non era vero. Cosí come non era vero che fosse un dongiovanni, quella era soltanto un’invenzione pubblicitaria. Mastroianni è un attore che ha passato in rassegna tutte le figure possibili e immaginabili dell’uomo, le ha passate sempre con un fondo di sorriso malizioso, ma insieme con quella visione, molto felliniana, un po’ sorniona e sorridente sulla cattiva condotta umana.
Tornando a Fellini, perché tra alcuni gesuiti (lei, padre Arpa, padre Fantuzzi…), c’è una sorta di contesa per cui ciascuno di voi rivendica di essere stato il piú vicino al regista?
No, non c’è nessuna contesa. Fantuzzi riconosce che ha potuto avvicinare Fellini per merito mio. Padre Arpa, poi… in esilio sono andato io, non lui. Voglio comunque precisare che siamo amici, non siamo in contesa. Dovrei anche precisare che padre Arpa è stato, ma non è gesuita, sebbene si senta ancora tale e desideri di essere riammesso (cosa che anch’io auspico di tutto cuore). Padre Arpa, infatti, già molti anni fa è stato estromesso dalla Compagnia di Gesú per un incidente di carattere finanziario, non morale o religioso. Come gesuita aveva lavorato molto bene a Genova, quasi un’istituzione in campo culturale, ed è stato uno dei pionieri in Italia, come il sottoscritto, nell’interesse pastorale per il cinema.
È riuscito ad incontrare Fellini prima che morisse?
No. Ho saputo troppo tardi che sul letto di morte aveva desiderato di riavere un contatto con me. Io non mi ero mosso per sfuggire anche alla sola ombra di piaggeria.
Nella vicenda della «Dolce vita», lei ha detto di essere stato il capro espiatorio. Si è sentito e si sente ancora adesso un incompreso?
Sono parole grosse. Non sono io l’incompreso. L’incompresa è la situazione pastorale. Non si sono ancora resi conto che oggi non si fa pastorale se non si cambiano mentalità e quindi modi operativi. In campo ecclesiastico, si è fermi a oltre mezzo secolo fa. Forse in pochi sanno che Blasetti, nel 1947, girò il film «Fabiola». Certamente, ancora meno sanno che fu prodotto da una società cattolica che voleva combattere la battaglia del cinema facendo film (io ero contrario in quei termini). Il primo fu appunto «Fabiola». Ma tutto crollò perché, per caso, Blasetti, in base a dei testi storici, fece sí che ad una martire in croce calasse una parte della vesta e si denudasse un seno. Automaticamente Blasetti divenne il «diavolo».