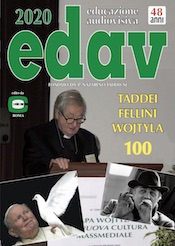�LA DOLCE VITA� DI FELLINI E LO STUDIO SCANDALO DI NAZARENO TADDEI
di NAZARENO TADDEI
L’incontro di quest’opera di Federico Fellini con il pubblico italiano è stato, come tutti sanno, eccezionalmente burrascoso. I consensi dei critici qualificati sono stati quasi unanimi; qualcuno ha invece reagito con intemperanze di fatto e di parole; altri hanno trovato nel film motivo di interessata speculazione; molti si sono gettati in una campagna scandalistica controproducente e per tanti aspetti moralmente dannosa; troppi hanno parlato senza la necessaria informazione. Pensiamo che, soprattutto in queste occasioni, sia compito di una critica seria e responsabile tentare di ricondurre la discussione entro i suoi veri confini, impegnandosi in uno studio approfondito di queste clamorose espressioni della cultura contemporanea. Non dispiaccia perciò al lettore se dedichiamo all’argomento un discorso piú lungo e circostanziato del solito. LA REDAZIONE
«La dolce vita» è un film cinematograficamente cosí pregnante da rendere impossibile il darne a parole un riassunto senza rischiare di omettere o di alterare fondamentali aspetti della sua complessa tematica. Ed è noto che quanto piú espressiva è l’immagine in quanto immagine, tanto piú lungo e difficile si fa il discorso che vuole ridirla a parole.
Ciò premesso cercheremo di guidare il lettore in una analisi dei vari aspetti del film, la conoscenza dei quali è pure indispensabile per un giudizio serio e motivato.
L’ossatura del film è costituita da una serie di incontri che Marcello — un giornalista sceso da Cesena a Roma — ha con vari personaggi, ambienti, fatti di cronaca.
Però «La dolce vita» è solo in parte la storia di Marcello, come del resto annuncia il titolo stesso. Vuole piuttosto essere la storia di quella vita «dolce», cioè quel clima molle nel quale Marcello viene sempre piú a trovarsi immerso, a mano a mano che si affievoliscono in lui le nobili aspirazioni con le quali era partito dalla città nativa. È un clima che 1o allucina, lo inebetisce. I richiami che provengono dalle varie situazioni, lo trovano sempre piú insoddisfatto del presente, ma anche sempre piú debole a reagire.
Marcello è il protagonista del film, ma non dei singoli episodi. Ognuno di questi episodi ha una sua fisionomia compiuta, con protagonisti propri, fra i quali Marcello si direbbe entri come ospite. Lo stesso si può dire degli altri personaggi (Maddalena, Emma, perfino Paolina) che accompagnano Marcello quale protagonista. Tuttavia, nei singoli episodi, egli non è un intruso, collabora anzi allo sviluppo degli stessi. Inoltre se ben si osserva, tale sua collaborazione avviene non per ciò che egli ha come personaggio-Marcello, ma per ciò che egli ha come partecipe, attivo o passivo, del fattore che è protagonista nel singolo episodio.
Ne consegue che «La dolce vita» è un film a episodi ma non nel senso classico del termine poiché la costante presenza di Marcello li lega tutti in una unità che non è solo esteriore, che non è solo la corda che tiene assieme i rami di una fascina. Questa presenza penetra negli episodi e contribuisce a chiarirne i significati. Ne va dimenticata l’altrettanto costante presenza dei «Paparazzi» (giornalisti e fotoreporters: Marcello è uno di essi) cioè di queste estremità a ventosa di quel polipo che si chiama pubblicità. La «La dolce vita» è il mondo a cui esse preferibilmente si aggrappano. E anche quando esse si aggrappano altrove (vedi episodio del falso miracolo), agiscono con la stessa brama e ridanno con lo stesso sapore quanto hanno succhiato.
«La dolce vita» è dunque un film a storia aperta cioè senza un vero inizio e senza una vera fine. Troviamo Marcello irretito nella «dolce vita» fin dall’inizio e ve lo lasciamo alla fine. C’è in lui un progresso di irretimento, ma su questo il film non pone l’accento.
Ci troviamo dunque di fronte a una struttura cinematografica inconsueta.
Fin dalla fase di preparazione, Fellini parlava del suo film come di un affresco; e questo è forse il termine piú esatto per definire il tipo di struttura de «La dolce vita». Tale struttura, per analogia (sotto il profilo della composizione, non del contenuto, ovviamente), fa pensare alle grandi composizioni pittoriche rinascimentali (si pensi per es. a «La scuola d’Atene» di Raffaello) dove attorno a un personaggio centrale si muovono gruppi ed azioni disparate. Quel personaggio entra nella vita di quei gruppi e ne anima le azioni per il solo fatto della sua presenza; senza di esso infatti i gruppi non avrebbero ragione di stare sulla parete. Quel personaggio poi è colto sí in un’azione narrativamente precisa, ma senza sviluppo di racconto (p. es. il «Cristo giudice»; il «Santo in gloria»; «Elio sul carro dorato»); e quella sua azione è precisata dal fatto di tutti quei gruppi che stanno attorno e non solo di uno di essi.
Una simile struttura nella storia del cinema è assolutamente nuova, per quanto ci consta, e anche solo sotto questo aspetto, essa rende il film di straordinario interesse, oltre che dargli un’ampiezza di respiro eccezionalmente vasta.
Evidentemente opera d’arte può essere tanto il piccolo ritratto o la miniatura, quanto la ciclopica concezione pittorica; anzi — nella fattispecie — un piccolo ritratto può essere un capolavoro, mentre una grande parete può non esserlo affatto; ma è innegabile che la grande composizione richiede una vastità d’ingegno che non tutti i poeti posseggono.
Finora il cinema ci ha dato magnifici film, talvolta mirabilmente profondi, ma chiusi nel ciclo di un racconto. Le spaziosità erano come quelle che si hanno guardando un grande panorama attraverso una finestra: per quanto ci si affacci essa costituisce pur sempre un limite.
Con «La dolce vita» il cinema ci dà anche un esempio di film a ciclo aperto; teoricamente la spaziosità non ha piú confini, come quando si guarda dalla vetta di un monte. Ci potrà essere la nebbia o la notte che ostacolano la visibilità effettiva, c’è comunque la possibilità della visione sconfinata. E sotto questo preciso profilo il film di Fellini è opera di estremo interesse e vòlta al futuro della storia del cinema. Data la natura di affresco, le consuete chiavi per una analisi cinematografica non reggono, se sono frutto di una preparazione empirica. Perciò non stupisce che qualche critico sia rimasto perplesso (di fronte all’arte, non al contenuto, del film) e che qualcuno addirittura abbia capito ben poco, accusando il film di non avere né capo né coda. Evidentemente in un film come questo, il capo e la coda non vanno ricercati nella storia, ma nei personaggi e nel tessuto che risulta dal loro stesso incontrarsi. In altri termini, ciò che interessa sono la loro realtà e non le loro vicende, il loro essere «personaggi» e non «protagonisti». A chi possegga questa chiave, non può sfuggire il tessuto veramente mirabile che Fellini ha saputo comporre. Tessuto tanto piú valido quanto piú dettato da una concezione unitaria, da una ispirazione incessante, che si rivela anche solo confrontando il film realizzato, con la sceneggiatura da cui è partito.
Fellini avrebbe potuto ideare altri episodi o episodi diversi e il film sarebbe rimasto sostanzialmente lo stesso, poichè esso nasceva da un ben preciso e profondo nucleo ispirativo. È dunque chiaro che la struttura è nata dall’ispirazione e non viceversa ed è altrettanto evidente che, in una cosí intensa compenetrazione dell’immagine col suo contenuto ideologico, l’analisi strutturale e cinematografica scivola immediatamente in quella tematica e viceversa.
Per cogliere il nucleo ispirativo di un film si può seguire una duplice via: quella che va dall’idea al film e quella che va dal film all’idea. Con la prima, nel nostro caso dovremmo rifarci alla vita di Fellini, alle sue esperienze, alle sue intenzioni, alle sue idee, alla sua sensibilità, al suo lavoro di preparazione e di realizzazione; con la seconda dobbiamo solo analizzare il film. Preferiamo la seconda (anche se ambedue le strade — in un caso come questo — ci porterebbero allo stesso risultato), poichè ci pare la strada piú precisa e piú giusta, dal punto di vista della critica cinematografica. Ciò che interessa è il film, come risultato concreto, come opera a sé stante e non l’autore o le sue intenzioni.
Cominciamo dal protagonista. Marcello è un ragazzo partito da casa con le consuete alte aspirazioni di chi tenta l’avventura nella metropoli. Ha delle doti, ha della cultura (vorrebbe scrivere un libro), ma non s’impegna mai sul serio. Accompagnando come giornalista la statua del Cristo lavoratore, si ferma a scherzare con le ragazze che prendono il sole. Con Maddalena sente il disgusto d’un amplesso sul letto di una prostituta, eppure vi si adagia. Con Sylvia è impressionato da questa Giunone che piomba nella sua vita e che resta con lui per una intera notte, ma non ha che pensieri sensuali; solo a un certo punto intravvede il fascino di un mondo piú liberato nelle bellezze autentiche della natura (scena della Fontana di Trevi), ma quel fascino rimane per poco in lui. Con Emma è innamorato e restio; non sa cogliere quello che di autentico e di pieno la donna gli vuol dare; e incessantemente la rifiuta e la riprende. Con Steiner sente il richiamo dei valori che l’avevano fatto partire da Cesena, ma lo accoglie solo per brevi istanti di commozione; e di fronte alla catastrofe dell’amico non sa scoprire in sé il bandolo di una sua soluzione interiore che quella tragedia gli offriva. Con Paolina è addirittura opaco pur sentendo che dietro l’innocenza di quella figura c’è il mondo dei veri valori. Di fronte al fatto religioso resta impassibile, sia per quanto esso ha di autentico (sebbene falso, quel miracolo scatena l’ansia del divino nella gente), sia per quanto esso ha di ripugnante (lo sfruttamento pubblicitario della falsità). Di fronte alla decisa reazione del padre dopo l’incidente occorsogli, non solo non ne sa cogliere il valore, ma tenta addirittura di frenarla, mosso da un misto di superficiale pietà e di vaga nostalgia. Di fronte alla miseria morale del gruppo di nobili sente forte il richiamo affettivo di Maddalena, lo segue e perfino lo insegue, ma ad interrompere la sua corsa basta una mano di femmina sconosciuta stesa nell’oscurità. Nell’orgia ne sente tanto la noia che si fa iniziatore di nuove trovate, ma si riduce a gettare piume in una stanchezza senza confini. Quando poi nel finale lo colpisce l’occhio del mostro e, al di là del fosso, la voce dell’innocenza lo richiama, non afferra il senso di quei gesti e di quelle parole e si lascia trascinar via, senza reazioni, senza energie, senza un briciolo di dignità.
In ogni situazione, Marcello si trova davanti a una porta aperta che gli permetterebbe di uscire dall’inautenticità della sua vita concreta, ma ogni volta si arresta come se non avesse la forza di fare un passo. Marcello è il personaggio piú rammollito, piú riprovevole di quanti si muovono nel film: perfino Maddalena, la donna che è arrivata all’abisso dell’abbiezione, è piú dignitosa di lui. Fellini lo guarda con amore come guarda tutti, ma non lo risparmia. Si direbbe che abbia fatte sue le parole della Scrittura: «Poichè sei tiepido... comincerò a vomitarti dalla mia bocca» (Apocalisse 3, I6). Tuttavia non crediamo che il film si possa definire pessimista perché Marcello rifiuta l’innocenza rappresentata da Paolina; anzi pessimismo dovrebbe aver luogo se venisse avvallato un ritorno all’innocenza senza travaglio interiore e senza impegno della volontà; poiché altrimenti si dovrebbe dire che hanno valore anche le verginità rifatte col denaro.
Emma è la donna che rappresenta la femminilità in ciò che essa ha insieme di bestiale e di angelico. Calda, innamorata, dedita, desiderosa di un nido vero e infrangibile, è costretta di fatto ad essere amante; ma si tratta di una situazione che non sopporta. Di qui i suoi scatti isterici, le sue gelosie insopportabili. Le scale dei pittori nell’appartamento — indice visivo di un nido interrotto a mezzo — sono il segno della comprensione penosa che Fellini ha per questa donna inappagata nel suo desiderio di autentica vita d’amore. Essa porta nel film l’elemento di una vita impedita nelle sue aspirazioni idealmente sane. Da una parte, Marcello rifugge dal cogliere i valori che Emma gli offre; dall’altra, Emma rende troppo angusto il respiro di questi stessi valori. Non stupisce che Marcello senta soprattutto il peso di tale amore geloso e violento; ma tanto meno stupisce che Emma voglia portare su un piano di fedele legalità la loro unione.
Maddalena invece tocca il vertice della turpitudine; eppure anche in essa c’è una brama di autenticità. È sempre in cerca di un calore umano (l’invito alle donne di strada, il colloquio della fontanella) che al momento buono non sa cogliere. Ella però paga di persona, con la sua profonda e spaventevole scontentezza, la turpitudine che di fatto preferisce. Anche questa donna dà il suo contributo tematico al film. La sua miseria e le sue brame sono gli indici rispettivamente di una realtà e di un ideale: praticamente gli stessi di Emma, di Steiner, dei nobili, di tutti.
Sylvia è il personaggio alle soglie del mito. Travolta dal mondo della vanità a causa della sua violenta bellezza, essa trova piena espressione nel contatto istintivo quasi bruto con le forze della natura: riesce a farsi rispondere dai cani, dimentica ogni cosa quando ha in braccio un gattino e negli scrosci da Olimpo dell’acqua di Trevi evade tanto dalla contingente realtà da sentirsi quasi sacerdotessa di una nuova concezione di vita, alla quale — con quelle gocce d’acqua gettate sul capo di lui — sembra voler iniziare pure Marcello. E quando gli scrosci cessano, la realtà li riprende improvvisamente. Anche Sylvia è impastata di miseria e di grandezza, indici di una realtà e di un bisogno.
Steiner è il personaggio che Fellini forse ha piú sentito e meno ha voluto spiegare. E’ il personaggio di una vita avvenire in cui ci sia finalmente il dominio dei valori autentici. Ma l’ansia e l’incertezza di questo avvenire lo opprimono tanto da spingerlo a uccidere i suoi bimbi perché non soffrano come lui soffre e a uccidersi perché non sa resistere oltre. È l’uomo che — ed è tremendo — degli affetti sente il peso; egli dovrebbe vivere nella solitudine. Si muove col passo della morte (ci appare la prima volta sullo sfondo d’una croce nera); sta tra gli altri uomini come un cipresso, alto, «guglia gotica», svettante, ma funereo. Il suo mondo si limita all’uomo come i cipressi di cimitero al corpo. E invece potrebbe, con la sua cultura e col suo equilibrio, dare un apporto alla società vuota nella quale si trova. Ma il suo intellettualismo è altrettanto vuoto e quindi sterile. Egli riassume le contraddizioni sparse nei personaggi del film; e la conclusione tragica della sua esistenza indica l’impossibilità di certe vie d’uscita.
Il padre di Marcello è l’unico personaggio che reagisce positivamente alla vita di inautenticità. All’inizio è succube anch’egli, come tutti, delle seduzioni della vita leggera (il braccio della statua nuda che domina l’inquadratura del tabarin è sentito come simbolo di questa imposizione alla quale egli si sottomette); ma dopo l’incidente nella casa della ballerina, capisce e fugge lontano dalla città tentacolare. Marcello non afferra questo richiamo, anzi vorrebbe trattenere il padre.
I nobili — tutti precisati individualmente, ma tutti accomunati in uno stesso clima — sono dei personaggi che portano nella propria carne il peso di una tradizione i cui valori si sono ormai svuotati e di cui è rimasto uno scheletro riempito di vanità. Quella specie di processioni verso la villa e, all’alba, prima dell’incontro con la principessa madre, assumono un carattere di impressionante nostalgia per un mondo di valori. La vita che essi conducono è una vita vuota, talora profanata. Essi inconsciamente aspirano ai valori ormai abbandonati. Nella vecchia villa entrano come alla ricerca di qualche rivelazione (là dentro infatti avviene l’evocazione spiritica). Aspirazioni e bassa realtà presente si mescolano in un impasto pietoso.
I personaggi dell’orgia rispecchiano nella varietà dei caratteri, dei tipi e delle occupazioni una tipica e sempre piú diffusa categoria del mondo contemporaneo, vòlta solo alla ricerca sfrenata di soddisfazione. Non sanno piú che cosa fare e per questo la noia si impossessa di loro. Quegli atteggiamenti stanchi di fronte a una azione eccitante, come potrebbe essere lo spogliarello di una donna bellissima, sono il segno della sazietà; eppure bramano ancora. I loro discorsi sono indice della loro povertà; il protrarsi della loro orgia è il segno di una incapacità a cercare qualcosa di piú valido. E la pioggia di piume che Marcello provoca nella sala all’alba è l’espressione — resa poesia — piú forte e piú tangibile del loro vuoto e insieme della loro brama di qualcosa che valga.
Paolina è il personaggio puro del film: è l’immagine dell’innocenza, non ideale ma reale (ricorda a Marcello gli angeli delle chiese umbre). Marcello se la trova davanti, improvvisa, senza un’apparente giustificazione, sia nella piccola trattoria della spiaggia, sia soprattutto nel finale.
Infine i fotoreporters che con la loro incessante presenza mettono a nudo ironicamente una realtà concreta della vita contemporanea. Ma basta pensare a certe inquadrature vivaci in cui le lenti degli obbiettivi si trovano di fronte agli spettatori come fossero loro puntate addosso, per intuire che questa presenza indica qualcosa di piú. Il film ritrae i fotografi mentre ritraggono la stessa realtà che il film rappresenta. Dentro quella gente che essi ritraggono, è inutile guardare, perché c’è solo il vuoto; di questa gente si può ritrarre solo ciò che appare all’esterno: come vestono, come mangiano, come fanno l’amore, come si divertono. L’incessante presenza di quei fotografi indica un bisogno di guardare dentro, di fotografare una realtà piú autentica; in una parola, indica un bisogno d’introspezione suggerito anche allo spettatore.
Da questa analisi dei personaggi e delle loro situazioni, è già possibile ricavare un significato tematico.
In tutti c’è l’ansia di qualcosa di autentico, mentre e poiché tutti vivono una vita inautentica. Pertanto sbaglierebbe chi volesse vedere nel film la messa in luce di certi ambienti romani. Roma è un puro mezzo di aggancio storico. In quelle persone, in quegli ambienti, in quelle classi, sono presentate tutte le classi, tutti gli ambienti, tutte le persone, còlte sotto il preciso profilo della non-autenticità di vita.
Il discorso è ampio, è universale. I nobili e i fotoreporters, i ricchi dei locali notturni e i poveri esseri che popolano le strade del film, hanno tutti un comune denominatore, vale a dire l’inautenticità della loro esistenza concreta e il bisogno scolpito nelle carni di una autenticità. Ciascuno di essi ha in sé i germi di quella autenticità, ma ciascuno li soffoca o li trascura o li sviluppa a modo suo.
E i valori autentici Fellini li indica nella natura vissuta quasi religiosamente (Sylvia), nell’amore inteso non solo come contatto sensuale (Maddalena) e come consacrata intimità (Emma), nell’arte e nel pensiero aperti a orizzonti luminosi (Steiner).
Di piú egli fa sentire che la brama per questi valori potrà venire soddisfatta da qualche altra cosa che sta al di là. C’è in tutto il film l’ansia di qualcosa di nuovo, di un’apparizione celeste (p. es. il desiderio che la Madonna appaia veramente, la processione dei nobili alla villa, l’impressione sparsa ovunque che da un momento all’altro qualcosa di inusitato debba avvenire), di una scossa ciclopica che laceri le pareti di questo mondo inautentico (il mostro dopo l’orgia soffocante). Marcello riassume tutte queste esigenze ed è lo specchio di ciò che oggi — in questa situazione spirituale — non si compie.
Esso si apre con un elicottero che porta il Cristo lavoratore verso piazza S. Pietro. In questa breve ma intensa sequenza c’è tutto lo stile, la potenza evocatrice e la chiave tematica del film. Duemila anni di venute del Cristo: esplodente dominio sui segni della potenza romana (l’elicottero sfila sugli acquedotti romani e l’ombra ne sottolinea il passaggio dominatore); ombra benedicente, non accolta, sulle case dell’umanità di oggi (l’ombra del Cristo sul bianco palazzo di periferia); qualche reazione curiosa e chiassosa (i ragazzi delle borgate, i due operai); un accenno devoto e simbolicamente messianico nelle ragazze che prendono il sole («Dove va?» chiedono); e su esse — subito — la rapace leggerezza dei giornalisti, espressione tipica del mondo contemporaneo. Nella grande piazza — segno di una raggiunta affermazione anche esteriore (il colonnato, le statue, il rombo delle campane) — il Cristo benedicente scende quasi coperto da quei giornalisti, la sua immagine si confonde contro i tetti e la piazza e non sembra piú quello stesso Cristo che poco innanzi proiettava l’ombra commossa sull’acquedotto e sulle bianche pareti dei palazzi.
Dov’è — nelle venute di oggi del Cristo — il netto staglio dominatore, perché spirituale, perché elevante? Dove va questo Cristo? Ecco la chiara formulazione di un problema da parte dell’autore. Egli interroga di fronte a questa realtà che è la realtà visibile di oggi. Cosí la domanda che Fellini mette in bocca alle quattro donne della terrazza è il perno introduttivo del film.
Giú nella piazza la folla attende guardando in aria; ma essa, piú che il Cristo, attende uno spettacolo.
Ed ecco improvvisa (balza dal basso dell’inquadratura e la riempie) l’immagine di un danzatore travestito da divinità orientale, in un locale notturno. Anche qui, gente che attende uno spettacolo. Al Cristo, s’è sostituita la maschera, l’esotico: travisamento di realtà con l’indice costante di un bisogno d’ultraterreno. (Un altro accenno di ciò lo si può vedere nella scenografia cinese della casa di Maddalena).
Da questo momento il film per tre ore ci presenterà ambienti equivoci, situazioni malsane, cose obbrobriose. Il racconto cinematografico lega strettamente queste sequenze a quella iniziale del Cristo, cosicché, cinematograficamente parlando, il Cristo scende sulla terra di oggi ed entra in quel mondo. «È Gesú... Dove va?», aveva fatto chiedere Fellini dalle donne della terrazza. La risposta aveva avuto inizio immediatamente con la folla di Piazza S. Pietro legata alla gente del night club e a tutto il resto del film. L’accennato elemento di violenta sostituzione del Cristo con la maschera orientale accentua il legame e, con questo, il significato di risposta che il film vuole essere a quell’interrogativo. Dalla luce del giorno della sequenza del Cristo si passa alla notte del night club. Quasi tutte le vicende del film si svolgeranno nella notte. Ci saranno però delle albe ed esse indicheranno il riaffiorare — piú o meno avvertito, piú o meno esplicito, piú o meno suasivo, ma con preciso significato — del Cristo in quel suo penoso cammino attraverso un mondo cosí corrotto.
Il Cristo è sceso nel mondo di oggi (abbiamo detto che il mondo de «La dolce vita» è solo narrativamente limitato a certi ambienti romani). Lo attraversa non visto, ma sentito nell’ansia indistinta di quel «qualcosa» che manca a quella gente. Si rivela, ma non è notato, nella suorina della clinica che appare al vertice di una panoramica verso la luce: c’è, ma è un contatto professionale col mondo di oggi. Non si rivela, ma è sentito distintamente, nel fremito per il divino della gente del falso miracolo. Si rivela, ed è sentito solo come contatto ufficiale, esteriore, nella Messa alla quale i nobili vanno dopo la nottata.
Finalmente, la rivelazione misteriosa e commovente nella scena conclusiva del film. Ancora una volta siamo all’alba. Paolina trasmette segni che Marcello non capisce e dice parole che egli non può afferrare per il rombo del mare. La fanciulla sorride serenamente su Marcello che se ne va. Avrebbe sorriso sul rifiuto dell’uomo se il suo fosse stato un richiamo sentimentale? Con quel suo sorriso in primo piano che chiude il film, Paolina sembra dire: «Io esisto, di fatto, al di fuori di te, anche quando mi rifiuti. Tu te ne vai col tuo branco; io resterò sempre qui. Tu te ne vai, al di là del fosso che ora ci separa, ma può darsi che dove tu vai, mi ritrovi ancora davanti. Io esisto.» E questi sono il sorriso, la tattica, la realtà della Grazia.
È un’intuizione splendida quella che ha guidato Fellini nell’aprire il film con la sequenza del Cristo e nel chiuderlo con quella di Paolina: l’intuizione dell’Incarnazione del Cristo che continua — sebbene non avvertita — nel suo Corpo Mistico e che si fa visibile attraverso il volto dell’innocenza in un mondo impastato di peccato. Ed è nella luce di questa imponente intuizione che si può capire il pieno significato tematico de «La dolce vita».
Analizzando la struttura del film, abbiamo rilevato il tipo di composizione ad affresco, interessantissima e nuova, ma ci siamo astenuti dal dire se il film fosse valido e bello. Ora dobbiamo affrontare questo giudizio.
La contemplazione estetica è data sostanzialmente dalla riduzione a unità di tutti gli elementi che compongono l’opera d’arte. Trattandosi di cinema e trattandosi di un’opera a contenuto, perché ci sia tale unità è necessaria anzitutto un’immagine veramente cinematografica e in secondo luogo la piena compenetrazione tra tale immagine e il contenuto che essa è chiamata ad esprimere. Ora ci pare che raramente il cinema abbia dato un esempio di maggiore cinematograficità dell’immagine e dimaggiore compenetrazione del contenuto nell’immagine e dell’immagine nel contenuto.
La difficoltà notata all’inizio di dare a parole il riassunto del film è la prova per assurdo di tale affermazione. Basti pensare solo all’episodio del padre, il piú semplice e il piú lineare. In una breve sequenza (p. es. quella del tabarin) ci sono parecchi e complessi contenuti: c’è, p. es., il significato di base (quello analizzato piú sopra); c’è la situazione dei personaggi in una precisa psicologia costitutiva ed esistenziale; c’è un esplicito raffronto tra queste varie psicologie, con estensioni che rivelano addirittura il contrasto di generazioni (vedi p. es. la differenza tra padre e figlio nei riguardi delle ballerine: il padre casca imbambolato, mentre il figlio e il suo fotoreporter quasi nemmeno notano gli elementi d’eccitazione che quelle esibiscono); c’è il clima di sentimenti sollevato nei vari personaggi (p. es. i riflessi diversi dei palloni di Polidor sull’animo della ballerina, di Polidor stesso, del padre di Marcello). E questo con lo stesso giro di immagini, grazie a piccole notazioni d’accento, di figurazione, di recitazione, ecc.
La prova diretta richiederebbe una troppo lunga analisi. Basti qualche accenno. Nella sequenza iniziale, l’uso significante dell’ombra e dell’elicottero; la sua presenza o la sua assenza nell’immagine a seconda che si tratti degli acquedotti romani, dei palazzi, degli operai, dei ragazzi, delle donne che prendono il sole. Nella sequenza del night club, la scenografia che crea come una serie di compartimenti stagni, che dà una sensazione di gabbia lucente, con quei personaggi che passano da un compartimento all’altro quasi viscidamente, a significare la schiavitú di certa vita e i sistemi obbrobriosi con i quali ci si muove là dentro. I toni della fotografia nella scena della trattoria con Paolina: toni bianchi intersecati, pacatamente ma tormentosamente, dalle ombre delle stuoie sul muro, degli oggetti, dei tavoli, cosí da rendere perfettamente l’idea di una figura la cui innocenza è da Marcello piú intravista attraverso una fitta grata che contemplata direttamente.
Si pensi ancora alle immagini di Emma che sta telefonando a Marcello, prima in piano ravvicinato, poi lontana attraverso un corridoio sul quale spicca la scala dei pittori, indice — si è detto sopra — di un nido interrotto; si pensi alla panoramica che dall’atrio della clinica a forti contrasti bianco-neri sale, attraverso la scala, sempre piú luminosamente verso la bianca figura della suora immersa in un biancore purissimo. Si pensi al fiore bianco agitato quasi ossessivamente da Marcello mentre sta per recarsi con Maddalena nella casa della prostituta e ai primi piani dei due personaggi addossati al muro. Si ricordino i toni scialbi nella scena dell’orgia, soprattutto alla fine durante la pioggia di piume; i chiarori del giorno — quel poco di giorno che c’è nel film — che contrastano con gli scuri e con le ombre dei personaggi; la violenza dei contrasti di tono nelle scene dell’aeroporto. Sono purtroppo accenni molto incompleti.
Fotografia, scenografia, recitazione, tutti gli elementi che concorrono alla realizzazione del film sono stati ridotti a unità dalla prepotenza di un’idea ispiratrice. Del resto, la cronaca delle riprese conferma per altra via quanto stiamo dicendo.
E poiché abbiamo fatto cenno alla recitazione, conviene che diciamo qualche parola sugli attori. Nessuno di essi, professionista o non professionista, rimane inferiore al compito che il film gli assegna. (Il debole doppiaggio della figura del sacerdote durante la scena del miracolo è un particolare secondario e non varrebbe nemmeno la pena di rilevarlo in un film cosí carico di perfezione). Marcello Mastroianni ha reso mirabilmente il suo personaggio. Anita Ekberg, nota comunemente per le sue qualità di donna formosa, è stata eccezionalmente brava e non solo ha saputo rappresentare se stessa, bensí è riuscita a dare al suo personaggio anche quell’aspetto di giunonica, olimpica forza che esso esigeva. Yvonne Fourneaux, un’attrice finora poco conosciuta e nordica, è diventata una calorosa donna mediterranea. Magali Noël è diventata la commossa ballerina del night club. Annibale Ninchi ha dato con grande intensità la figura del provinciale anzianotto sceso a Roma. Ma è impossibile citarli tutti. Tutti però, anche i piú secondari, portano l’impronta di un’arte mirabile. Si pensi solo al personaggio del terzogenito dei nobili, alla giornalista americana dell’orgia, a Paolina pur nella semplicità dei suoi mezzi e nella esiguità delle prestazioni che le erano richieste. Un simile risultato della recitazione, che deve evidentemente parte del suo esito — oltre che alla bravura degli interpreti — all’intelligenza degli altri collaboratori quali il truccatore, l’illuminatore, ecc., depone in maniera inequivocabile circa la violenza dell’ispirazione del regista che ha piegato tutta la materia all’unità dell’idea.
L’unità di struttura, poi, si realizza nell’insieme e attraverso l’immagine anche mediante i ritmi che rispecchiano i ritmi dell’idea. Per fare un solo esempio, il ritmo della scena del padre a un dato punto diviene concitato e si tronca, esprimendo cosí la resipiscenza decisa del padre; per contrasto, si noti la lentezza quasi angosciosa della scena dell’orgia. Né si può dire — come qualcuno ha creduto di dover dire — che Fellini, per dare il senso della noia, ha annoiato. Quella scena può annoiare solo chi non ne sa leggere i valori espressivi. Dal punto di vista estetico, il film è un canto continuo di ispirazione fantastica, di creazione immaginificamente espressiva.
Ci pare lecito concludere che «La dolce vita» resterà nella storia del cinema e al cinema aprirà nuovi orizzonti per la sua formula di base, per il suo linguaggio cinematografico pieno e nuovo, per la compiutezza dei suoi ritmi; in una parola, per la sua poeticità; poichè poesia è esattamente la spiritualità della materia come materia.
Per quanto complessa, la tematica de «La dolce vita» può ridursi sostanzialmente a quanto abbiamo cercato di fissare nell’analisi fatta piú sopra. Tutti gli altri elementi, per quanto ricchi ed originali, contribuiscono a fissare e dar significato a quel filone tematico centrale.
Fellini constata l’inautenticità di certo modo di vivere tipico del nostro tempo, constata l’ansia di una autenticità che tuttavia permane nel fondo degli spiriti e che si rivela nell’incapacità a soddisfare quella vita; intuisce quali siano le porte aperte su quella autenticità e intravede tutto il valore della soluzione cristiana.
Pertanto non si saprebbe come non approvare ed apprezzare una tematica del genere.
Tuttavia due osservazioni si impongono. La prima: l’intuizione — ripetiamo: splendida — dell’Incarnazione del Cristo resta solo intuizione. In altri termini, gli elementi che definiscono l’autenticità in chiave esplicitamente cristiana, se sono potentemente intuiti, non sono altrettanto efficacemente sviluppati.
La presenza di Paolina, per quanto incisa e vigorosa, è troppo fugace. Fellini l’ha sentita come realtà (ed è magnifico), piú che come simbolo, di Grazia, ma non ne ha sentito lo sviluppo. Nella sequenza iniziale, il senso del «Dove va?» è attutito dall’irruenza del racconto immediato e dai contrasti che riempiono quella pregnante sequenza. Il significato pur evidente della «discesa » del Cristo resta troppo velato nel complesso del film, proprio per una mancanza di peso strutturale nella economia complessiva; la fugace apparizione della suorina della clinica, il senso religioso del miracolo, l’accenno della Messa, sono notazioni sporadiche (anche se felicissime) e non fasi di uno sviluppo strutturale e tematico. In tal modo, la chiave cristiana di una vita «autentica» resta troppo poco differenziata dalla chiave naturalistica (Sylvia, ecc.) e il significato del suicidio di Steiner assume una velatura di tematica pessimistica.
Questo ovviamente attenua, ma non distrugge il valore positivo del film.
La seconda constatazione ha elementi comuni con la prima. La mancanza di sufficiente sviluppo strutturale dell’intuizione dell’Incarnazione non le permette di precisarsi meglio; e nell’economia concreta del film lascia adito al sospetto che ci sia bisogno di una nuova rivelazione o comunque di qualcosa di nuovo che renda possibile l’Incarnazione stessa. Oggi, di fatto — sembra dire il film — il Cristo è incarnato in una Chiesa esteriore che ha col mondo solo dei contatti professionali (la suorina) o ufficiali (la Messa) ed è invocato da un popolo desideroso che si riveli anche al di là dei modi canonici di giudicare di un’effettiva rivelazione (la gente del falso miracolo, la frase della signora con Yvonne nella stessa sequenza).
Questa constatazione, in un senso limita ulteriormente il valore cristiano del film, ma in altro senso introduce un discorso di larga portata tematica, discorso che non può essere condotto con le chiavi tradizionali e che diviene impossibile tra due persone che lo facciano ciascuna in chiavi diverse.
È certo che ci troviamo in un momento della storia in cui si chiude un’èra e se ne apre una nuova. Èra in cui, al trionfo dei valori — per intenderci — umanistici, succede il trionfo dei valori tecnici; in cui all’uomo individuo succede l’uomo membro di una società o, diciamo piú crudamente, di una massa; in cui al linguaggio della parola succede il linguaggio dell’immagine con tutto ciò che questa diversità di linguaggio comporta nella vita del pensiero e dell’azione.
In questa nuova èra è ancora e solo il cristianesimo che può dire una parola autentica. Oggi il cristianesimo, non sul piano dogmatico ma su quello pratico, sta ancora cercando questa sua parola e la ricerca purtroppo non è senza ostacoli. La nuova parola del cristianesimo sarà indubbiamente una parola che non trascurando nemmeno un’apice della Rivelazione e del dogma non sarà piú ancorata a sovrastrutture attualmente inutili: cosí infatti è avvenuto in ogni epoca della Chiesa. Sarà una parola che si rifarà alle origini, arricchita di quanto i venti secoli hanno apportato di valido e di perenne.
«La dolce vita» apre la prospettiva su questo futuro e afferma la necessità di valorizzare tutto e solo ciò che è autentico.
Sotto questo profilo il film è un documento (non un documentario, come qualcuno ha scritto) e un testimone dell’èra che tramonta, èra in cui si assiste al crollo di tutti i miti. Crolla il mito della donna, gettata nell’abbiezione e insufficiente ad alimentare la vita di un uomo; crolla il mito della nobiltà, ridotta a larva di grandi tradizioni; crolla il mito della cultura, che porta al suicidio; e in un certo senso crolla anche il mito della religione, se per religione si intende certa esteriorità e certo formalismo.
La prospettiva del film sul futuro contempla un mondo senza miti. Infatti, donna, nobiltà, cultura, religione crollano perché miti, non perché realtà in sé stesse valide. Evidentemente qualora non si avvertano le necessarie distinzioni, può verificarsi il pericolo di trascurare anche ciò che è perenne e valido e di accentuare il senso naturalistico di certi valori. Tuttavia, superata la crisi protestantica, anche i valori naturali possono e debbono essere considerati con maggiore serenità.
In questo senso «La dolce vita» resta ancora un film sostanzialmente cristiano, nonostante le sue incertezze o almeno — nella piú severa delle interpretazioni — un film precristiano, in quanto, dopo aver testimoniato il crollo dei miti nell’èra che muore, prospetta le basi naturali sulle quali si profila e può radicarsi l’esigenza cristiana.
Un’ultima considerazione. «La dolce vita» è un film «a tema», non «a tesi», un film cioè il cui nucleo ideologico non è espresso in forma assiomatica e di messaggio, bensí è rappresentato dallo speciale angolo visuale o dal particolare stato d’animo con cui è considerata dall’autore la materia che tratta.
Fellini guarda con amore i suoi personaggi; egli rivede se stesso in qualcuno di essi e in molte delle situazioni che descrive. Di altre situazioni invece ridà la emozione provata nell’apprenderle dalla cronaca o dalla vita. Ma questo amore non si riferisce a ciò che ivi c’è di riprovevole, bensí a ciò che ivi, pur nell’abbiezione, c’è di valido o di degno di commiserazione.
Inoltre l’amore che egli ha per i suoi personaggi e anche per le situazioni che descrive, non gli impediscono di mettersi in un atteggiamento critico: molte volte c’è l’ironia (si pensi solo agli assalti dei fotoreporters, alle situazioni di Marcello, alle scene del castello dei nobili); altre volte c’è l’amarezza, il disgusto, la noia. E poichè questa ironia, questo disgusto, questa amarezza e questa noia sono frutto congenito della sua ispirazione, tali sentimenti sono quelli che di fatto si trasmettono immediatamente allo spettatore.
Concludendo: questo nuovo film di Fellini non solo ha aperto una nuova strada cinematografica, ma ha fatto col cinema un’opera imponente di pensiero e di pensiero perlomeno naturaliter cristiano. Un’opera tra le piú vive sulla crisi del mondo contemporaneo e sulle prospettive future dell’umanità.
Anzitutto conviene distinguere subito tra «moralità» e «visibilità» (dal punto di vista morale) di un film.
La moralità di un film ha due aspetti: è determinata da ciò che il film fa o dice o sostiene in se stesso, cioè prescindendo dall’influsso che può esercitare sullo spettatore (moralità assoluta); oppure da ciò che il film ha di oggettivamente atto a influire moralmente sullo spettatore (moralità relativa). Le eventuali intenzioni buone o cattive degli autori non possono entrare come elemento di giudizio obbiettivo, se non in quanto il film ne rechi l’impronta effettiva.
La moralità «assoluta» è determinata anzitutto dal suo contenuto tematico. Per «La dolce vita» tale contenuto, come s’è visto, è nettamente positivo pur con le riserve notate. Inoltre è determinata anche dall’osservanza delle leggi morali cui il film — quasi azione umana estrinsecata — è sottoposto. Sotto questo aspetto, ne «La dolce vita» si presenta il problema della rappresentazione del male. I principi enunciati in proposito da Pio XII (pubblicati nel numero scorso — vedi «Letture» I960, II,138) non lasciano dubbi.
Nel film, la perversità e il male non «sono offerti in ragione di loro stessi» bensí in funzione del disgusto e del superamento; non «risultano nemmeno di fatto approvati» come dimostra quanto s’è detto piú sopra e l’analisi di ogni singolo dettaglio; non «è descritto in forme eccitanti, insidiose, corrompitrici», almeno per persone psicologicamente sane o moralmente mature anzi tutti quelli che lo hanno visto senza pregiudizio hanno notato l’assenza di compiacenze e la volontà di non debordare nel morboso, come purtroppo invece succede comunemente in altri film che talora passano inosservati anche dai piú severi censori. Infine si può dire che il male costituisce «parziale contenuto nell’intera azione del film», sia perché in ogni episodio l’aspetto di inautenticità è contrapposto a quello di autenticità, sia perché il male generalmente non è rappresentato direttamente, ma solo direttamente accennato.
La moralità «relativa» è determinata dal potere obbiettivo del film di: a) fornire idee, morali e immorali; b) creare delle suggestioni che interessano comunque il campo morale e c) insegnare praticamente come si fa il bene o il male.
Per l’aspetto delle idee, ne «La dolce vita» ci si deve rifare al suo valore tematico sostanziale, osservando tuttavia che non tutti sono in grado di coglierlo. Piú accessibile invece è il carattere di riprovazione per quel genere di vita.
Per l’aspetto delle suggestioni, abbiamo già notato l’assenza di compiacenze allettanti e dobbiamo aggiungere che la suggestione che il film crea è soprattutto di disgusto e di noia. Ciò non toglie che la materia stessa, il fascino fisico delle persone che si muovono nel film, la crudezza della rappresentazione di certi ambienti siano tali da far destinare la visione solo a un pubblico limitato e ben preparato; ma questo è già problema di visibilità.
Per l’aspetto dell’insegnamento valgono analoghe considerazioni. Non è male il solo far conoscere come si faccia il male (altrimenti, p. es., sarebbe cattivo l’insegnamento della casistica nella teologia morale); ma evidentemente non si possono commettere certe azioni se non si conosce la maniera di compierle. Di qui (ma è ancora problema di visibilità) la necessità di precauzioni e di ragioni (rationes proportionate graves) che giustifichino quella conoscenza. Comunque, le azioni che questo film potrebbe insegnare, purtroppo non sono del tutto nuove per il grosso pubblico delle sale cinematografiche italiane
Pertanto dal punto di vista della intrinseca moralità, sia assoluta, sia relativa (ripetiamo: non della visibilità), «La dolce vita» può essere ritenuto un film sostanzialmente positivo pur con tutte le sopraccennate riserve.
La visibilità invece riguarda direttamente lo spettatore di fronte al film. Dunque due elementi: «spettatore» e «film». L’elemento «film» è determinato in base alla moralità intrinseca relativa di cui s’è detto. L’elemento «spettatore » richiede un discorso che non si può esaurire in questa sede. Ci limiteremo a prospettare il duplice aspetto fondamentale della lettura e delle categorie di spettatori.
Anzitutto il problema di lettura. Un film è opera di linguaggio e come tale deve essere sottoposto a lettura. Ma l’immagine e tale segno da essere immediatamente intuibile nel suo aspetto materiale (p. es., l’immagine di una seggiola vuota dice «una seggiola vuota») e da poter offrire — già in tale aspetto — determinate idee anche se di fatto lo scopo dell’immagine sia quello di far un discorso d’altro genere (p. es. una seggiola vuota, rappresentata per dire l’amarezza di un distacco). Bisogna quindi distinguere varie fasi di lettura: la piú elementare è quella che si ferma alla materialità dell’immagine e alla materialità del racconto; di essa si tiene conto quando si fanno film per bambini i quali difficilmente riuscirebbero a cogliere ulteriori significati. A questa prima lettura, «La dolce vita» parla, p. es., di un giornalista che si trova in determinate situazioni, di nobili in un castello, di Roma, ecc..
Una seconda lettura è quella che permette di scoprire almeno alcune note tematiche e, magari aiutandosi con elementi emotivi di simpatia o simili, riesce a dire allo spettatore cose non dette materialmente dall’immagine. «La dolce vita» in tale fase di lettura dice almeno il disgusto per la vita rappresentata in essa.
Un ulteriore lettura — che può avere diversi gradi a seconda della preparazione dello spettatore — è quella che scopre gli aspetti tematici veri e propri, portati al loro livello universale. Per «La dolce vita» è il caso del significato tematico che ci siamo sforzati di illustrare qui sopra.
Non è certamente da tutti — soprattutto in un film cosí complesso e cosí pregnante (oltre che cosí cinematografico) e soprattutto con una sola visione — riuscire a leggerne tutta la ricchezza e tutta la complessità dei temi. Ma non ci sembra nemmeno equo giudicare la visibilità di un film in base al suo primo grado di leggibilità. Generalmente oggi il grosso pubblico ha raggiunto in gran parte il secondo grado di lettura e si deve aggiungere che i giovani riescono a «leggere» i film meglio degli anziani, soprattutto quelli — e non sono pochi — che frequentano circoli di cultura cinematografica o seguono le recensioni della critica.
Si deve poi aggiungere che il disgusto provato da molti è solo occasionato dal film, mentre in realtà è provocato dalle cose che esso rappresenta e dal modo con cui le rappresenta. Perciò chi confonde il disgusto per quel genere di « vita» con il disgusto per il film che la descrive, cade nell’equivoco e non avverte che proprio questo disgusto depone a favore del film in quanto esso è riuscito a far sentire l’amaro di cose generalmente allettanti.
Il problema delle categorie di spettatori è pure fondamentale per la visibilità, ma purtroppo esso è di enorme complessità e forse praticamente insolubile.
A voler essere al massimo giusti nel formulare il giudizio di visibilità, bisognerebbe darne uno per ogni spettatore, tenendo conto della sua capacità di lettura, del suo temperamento, del periodo psicologico che sta passando, delle ragioni che lo spingono a vedere un film, della sua formazione spirituale ecc.. Poichè ciò è praticamente impossibile, si potrebbe tentare di racchiudere gli spettatori in diverse categorie e per ciascuna di queste stabilirne un giudizio. Ma non è chi non veda quanto complessa, quanto difficile e quanto numerosa dovrebbe essere una simile catalogazione. Lo studente di città non è lo studente di campagna; in città, lo studente non è l’operaio, il giovane non è l’adulto, il trentenne sposato non è il trentenne celibe; lo studente di liceo non è la studentessa di liceo; lo studente di una scuola pubblica non è lo studente di un collegio religioso ecc.. Un giudizio di visibilità quindi, basato sulla catalogazione degli spettatori, ci pare cosa praticamente assurda.
Che dire, dunque, de «La dolce vita» sotto questo aspetto? Escluso il giudizio in base alla catalogazione degli spettatori, non resta che quello in base alla capacità di lettura.
Non si tratta certo di un film di facile lettura; d’altra parte è anche vero che — esclusa la lettura materiale — esso è tale da creare il disgusto per quella certa vita.
Restano — senza reticenze — tutti i pericoli accennati sopra. Certamente «La dolce vita» era film da destinare a visioni limitate o almeno a persone opportunamente preparate. (Nazareno Taddei SJ)
Lo studio su «La Dolce vita» contenuto nel numero del marzo scorso di «Letture», ha raccolto da cattolici sinceri approvazioni sincere per il rigore dell’analisi e della sintesi, e anche forti disapprovazioni per l’impressione di quasi incondizionato elogio. Noi sentiamo soprattutto le ultime e forse nessuna lode potrà compensarci del biasimo di aver dato fosse pure solo un’inopportuna occasione di scandalo.
Vogliamo qui dichiarare anzitutto, a costo di subire strascichi di critiche e insinuazioni da ogni parte, che il nostro studio e la valutazione morale in particolare, non intendevano distaccarsi e tanto meno correggere il giudizio normativo del C.C.C.. Se tale presunzione risultasse dallo studio, sia chiaro che ciò non rientrava in alcun modo nelle nostre intenzioni.
Nell’insieme lo studio può essere apparso un’esaltazione del film, e le poco rilevate riserve sul piano della moralità assoluta possono aver dato l’impressione di infirmare l’efficacia delle rilevanti riserve sul piano della moralità relativa e della visibilità.
La distinzione tra giudizio di valore e di visibilità ci pare giusta e doverosa in sede teorica e scientifica, ma ciò è ben lontano dal significare che sia lecito lanciare sul mercato un film visibile a pochissimi, e che non sia da condividere la sigla «escluso per ogni genere di pubblico». Ed è ovvio quindi che tutti i critici cattolici devono dosare opportunamente la loro critica in modo che la verità del giudizio integrale dell’opera non distrugga nella mente delle masse e dei loro facili imbonitori — cioè di certi giornalisti — la chiarezza e l’efficacia del giudizio morale di visibilità.
Purtroppo quasi ognuno trova ormai da sé ragioni o pretesti per giustificare la lettura di qualsiasi libro e la visione di qualsiasi film, e saremmo veramente addolorati se si dovesse constatare che il nostro studio critico sia servito di pretesto per eludere le norme dell’Autorità Ecclesiastica.
Pertanto è doveroso sottolineare e in parte sviluppare le riserve già contenute nello studio di marzo e precisamente quelle che hanno fatto concludere al nostro severo giudizio di visibilità.
La prima è quella che si riferisce alla violenza e pericolosità dell’immagine. Purtroppo ci sono ancora molti, la cui immaginazione morbosa sorpassa i limiti che l’immagine offre.
È un errore escludere che ci siano persone sane premunite contro la seduzione dell’immagine, ma è anche errore presumere che non sia, di fatto, ostentata la superiorità di molti nei confronti di tale seduzione.
Alla luce di queste osservazioni è evidente che l’immagine e soprattutto quella a carica emotiva o addirittura erotica resta ambigua e di tale ambiguità non si può non tener conto. Il discorso quindi vale per quanto di male «La Dolce vita» rappresenta soprattutto in certi suoi punti culminanti rappresentati a modo di realistica e laica confessione di particolari come fosse quella di un figliol prodigo, non ancora convertito, ma solo profondamente deluso, benché ancora incantato dietro quelle morbose immagini.
Salva perciò ogni intenzione del regista e per quanto certi temperamenti, piú o meno coerenti nella vita, eppur sensibili alle suggestioni morali liricamente contenute nella piú scabrosa materia, rilevino e sentano questa stessa intenzione, dobbiamo ammettere che molti possono rimanere morbosamente allettati o male impressionati o scandalizzati.
Non vorremmo che si insinuasse, con la scusa del film eccezionale, uno pseudo principio: cioè che sia lecito rappresentare il male anche in forme pericolose col pretesto che il male viene denunciato e condannato. Contro tale principio la nostra Rivista si è sempre schierata, e ne sono prova le severissime recensioni contro certi film che purtroppo hanno invaso incontrastati gli schermi italiani. E ci chiediamo preoccupati dove vada a finire la licenza poetica e morale dei registi e produttori, che — contenti di eludere certi canoni superficiali della censura — riempiono sempre piú i loro film di autentica anche se velata pornografia, soprattutto se si approva o si possa far pensare che in qualche modo si approvi un tale genere di film. Sappiamo tutti come basti non opporsi intelligentemente su tutto il fronte perché da un solo punto confuso e debole cominci il travolgimento di ogni giusta barricata contro la rappresentazione pericolosa.
Se la bellezza dell’opera d’arte può per un verso innalzare l’interesse dello spettatore a un livello superiore alla seduzione morbosa, la stessa bellezza può per un altro verso aumentare e coprire con l’arte la seduzione stessa. Distinguere è difficile spesso. Comunque, riconoscere i valori estetici non può voler dire approvare gli eventuali pericoli morali. E lo stesso si deve dire anche nel caso che il senso tematico del film conduca a una netta riprovazione del male mediante una pericolosa rappresentazione del male stesso. Anche in questo caso, benché corretta nel decorso della rappresentazione e forse nella conclusione dello spettatore, resterebbe la forza ambigua dell’immagine.
Quando poi la contrapposizione del bene al male non è chiaramente e validamente rappresentata per la massa, il giudizio morale deve essere ancora piú severo.
Qualcuno potrà dire che l’esigenza di tale chiara contrapposizione è popolare, è semplice. E sia; ma bisogna tenerne il dovuto conto. L’eccezione, e cioè la non rappresentata contrapposizione del bene, limitarsi cioè alla pura rappresentazione della noia e insoddisfazione del male, sarà consentita appunto come eccezione e purché non ambigua e pericolosa, come già si è detto.
Ne «La Dolce vita» di Fellini la contrapposizione del bene, il Cristo e Paolina, è pallida e impotente. Lo struggimento di quel bene estraneo ai protagonisti veri della «dolce vita», non tutti lo potranno bene afferrare e lasciar fermentare in sé. Molti non percepiranno tale salutare nostalgia, seppure non assorbiranno un senso di desolazione, quasi che quello sia un mondo di predeterminati e inghiottiti dal male.
Speriamo bastino questi chiari e semplici cenni a dissipare l’impressione che la nostra Rivista si sia voluta scostare in questo caso complesso e clamoroso da quei criteri di equilibrio, cautela e attenzione nel giudizio morale dei film che hanno sempre ispirato e ispireranno le recensioni di tutti i critici cattolici.