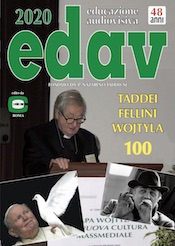VERIT� DEL DOCUMENTARIO
di NAZARENO TADDEI
Edav N: 341 - 2006
Prima che sociale o etico, il discorso sulla verità del documentario è teorico, linguistico e gnoseologico.
Esso, in verità, è meno teorico di quanto non sembri a prima vista, poiché la sua incidenza pratica – dalla fattura all’artisticità o moralità o funzionalità del film – si mostra non appena siano scorse le prime inquadrature di un documentario o si vada a cercare quanto di conoscenza autentica della realtà giunga dalla mole del documentario che ci capita di vedere. E il discorso estetico non è certo sufficiente a darcene il perché.
È tuttavia un vero discorso teorico, perché si riferisce alla natura del linguaggio cinematografico, con tutti i suoi addentellati con i problemi piú ampi della conoscenza e della rappresentazione della realtà e anche – se si vuole – dell’estetica.
Come ogni linguaggio, anche quello cinematografico è comunicazione. E prima ancora è espressione. Chi «parla», infatti, «dice» in qualche modo a se stesso un certo contenuto mentale e poi lo «esprime» (attraverso il linguaggio esterno, appunto) fuori di se. E con ciò, comunica.
La comunicazione è una delle fonti di conoscenza ma non è l’unica. C’è infatti, p.e. la conoscenza per esperienza diretta.
Pare piccola o banale osservazione, tant’è ovvia. Ma è importante, perché fondamentale. Ed è complessa. Ed è attuale, perché non sempre viene tenuta nel debito conto da chi s’interessa a questi problemi, soprattutto nei confronti del cinema; e le conseguenze non sono leggere.
Il cinema infatti è tale linguaggio da presentare i propri «segni» (le immagini) come rivestiti dell’aureola della realtà che essi rappresentano. Cosicché si crede di cogliere la realtà, mentre se ne coglie solo il segno; si crede di conoscere – quasi per esperienza diretta – la realtà rappresentata, mentre di fatto se ne coglie solo l’immagine. Certamente c’è una conoscenza per esperienza diretta anche nel cinema. Ma l’oggetto di essa è l’immagine e non la realtà che questa rappresenta: la cosa rappresentata viene conosciuta solo attraverso una specie di sipario – vedremo subito, assai deformante – che è l’immagine.
Tale sipario è, vorrei dire, di doppio tessuto. Non solo la realtà rappresentata subisce una imprescindibile deformazione nel venire rappresentata, bensí essa non costituisce nemmeno ciò di cui il cinema – in quanto linguaggio – direttamente s’interessa con i suoi segni. Questi segni infatti la rappresentano materialmente per essere veicolo d’espressione d’un contenuto mentale dell’autore. Solo questo contenuto mentale, eventualmente, avrà per oggetto la realtà rappresentata dall’immagine.
La realtà rappresentata, dunque, pur potendo interessare – come realtà – l’autore delle immagini, in quanto «rappresentata» è solo un tramite di cui l’autore si serve per esprimersi.
A questo punto il discorso si riversa sull’autore e sul suo rapporto tanto con la realtà (di cui vuol dare conoscenza) , quanto con l’immagine di cui si serve per esprimersi. (1)
E il problema della verità cinematografica segue in conformità.
L’autore conosce una certa realtà e già in questa fase ci può non essere «verità», cioè adeguazione tra la realtà e la conoscenza che egli ne ha; e la esprime, e anche in questa seconda fase ci può non essere «verità», perché l’immagine può non esprimere fedelmente quanto l’autore intendeva. Cioè può non esserci adeguazione tra la significatività oggettiva dell’immagine e il contenuto mentale che dovrebbe esserne significativo.
Come si vede, il sipario è abbastanza spesso e molteplice.
Nel documentario, poi, il problema del sipario si pone con prepotente irruenza, poiché il documentario dovrebbe (o vuole) servire proprio a rappresentare la realtà, a sostituirsi nella conoscenza della realtà per esperienza diretta. Vorrebbe – in altri termini – essere senza sipario; ma di fatto non può esserlo.
La realtà é una parola di moda; e lo è sempre stata. Dal realismo ilemorfico degli Scolastici al realismo storico dei marxisti o al fenomenologismo dei postesistenzialisti (ma si può arrivare all’indietro fino alle origini conosciute del pensiero umano), questa parola sacrée rimbalza di epoca in epoca. La realtà. E cos’è questa benedetta realtà? Gia, è la res (e oggi si dice perfino «reificare»!), ciò che è, lí, fuori di noi, con una sua autonoma esistenza, sia che la conosciamo, sia che non la conosciamo. Anche noi siamo realtà; ed è realtà anche il nostro pensiero, la nostra stessa conoscenza della realtà. D’accordo. Ma chi interpreta in un modo e chi in un altro, a causa di tutti quei problemini secolari che affiorano non appena si voglia vedere un po’ piú a fondo in tutti quei rapporti che scappan fuori: la res, noi, la conoscenza ecc.
A noi interessa, tutto e solo in quanto il documentario – detto in parole povere – è il film della realtà.
E cos’è dunque questa realtà? Quantitativamente è tutto ciò che esiste: documentario sulla Resistenza e sugli ultimi virus o antivirus di mirabolanti provette; documentario sulle Isole Canarie e su quello che i postelegrafonici oriundi pensano dell’ultima canzone dei Beatles (forse questo lo chiameremo film-inchiesta, ma le specificazioni sono all’interno d’uno stesso genere).
E cos’è? Eh, se lo sapessimo veramente... non saremmo qui a crogiolare d’estate e a tremare d’inverno! «Saremmo – dice il Matto in LA STRADA – il Padreterno!»
Però qualcosa possiamo pur dire. La realtà è qualcosa – diciamo – «dentro» ed è qualcosa – diciamo – «fuori». Non disturbiamo Kant col noumeno e col fenomeno, ma siamo lí (a parte ogni valutazione filosofica): non disturbiamo Marx e tutti gli altri pro o contro, ma siamo li. Discutano pure: è questione di capire – talvolta – che le cose sono piú semplici di quello che non sembri e che, giunti a quel certo limite in cui non sono piú poi cosí semplici, è inutile sforzarsi di raccogliere il mare in un cucchiaio. È sempre questione di piani e di livelli: è questione di non confondere... la sostanza con gli accidenti. Comunque, si può veramente dire che una seggiola è una seggiola, che un uomo che cammina è un uomo che cammina e che – alla fin fine – ogni realtà dell’universo è qualcosa in se stessa ben definita (anche se non sempre da noi ben definibile) ed ha dei «contorni» con i quali essa si presenta.
Ed eccoci al cinema. L’immagine cinematografica è «segno» dei contorni concreti, sensibili, materiali delle cose. La bellezza non ha contorni; ha però contorni una cosa bella; e una cosa manifesta la sua bellezza (interiore o esteriore) attraverso i suoi contorni.
L’immagine cinematografica «riproduce», «rappresenta», «raffigura» questi contorni. Se cinema muto, solo contorni visivi; se cinema sonoro contorni visivi e sonori, cioè audiovisivi.
A questo punto, ritorniamo... al nostro sipario: a) il cinema è linguaggio e quindi l’immagine esprime un contenuto mentale del suo autore; b) l’immagine cinematografica deforma di fatto i contorni della cosa rappresentata.
Come dunque ci può essere verità del documentario a queste condizioni; cioè una resa cinematografica fedele e adeguata di una realtà?
Il sipario è duplice. Non solo, ma al di qua e al di là di esso c’è qualcosa che complica ancor maggiormente le cose.
Fermiamoci pure al solo sipario.
L’immagine cinematografica deforma la realtà ripresa, anche solo nei suoi contorni. L’asserzione non vale in maniera assoluta per tutti i casi, ma quelli che si salvano sono talmente ristretti e parziali che la generalità dell’asserzione si può e si deve sostenere.
L’immagine cinematografica è bidimensionale, mentre la realtà è generalmente tridimensionale. Quando di questa realtà tridimensionale mi interessa cogliere solo una sua facciata (diciamo cosí) bidimensionale, ecco che il divario tra immagine e realtà nei rispettivi contorni è già ben diminuito. I casi sono ridottissimi: voglio avere l’immagine di una pagina scritta, di un disegno, di una pittura. Se non c’è nulla di rilievo che mi interessi cogliere (una pennellata grossa, una scrittura calcata che passa il foglio ecc.), la bidimensionalità dell’immagine non deforma sostanzialmente i contorni di quella realtà. Ma e gli altri aspetti: grandezza, formato, misura, durata dell’immagine in rapporto alla durata di quella realtà?
Per l’immagine sonora il problema si ripropone pressoché identico nel fatto della stereofonia.
Questa è la prima enorme deformazione che l’immagine cinematografica (visiva e audiovisiva) apporta nella rappresentazione che essa fa della realtà. Ma non è l’unica. Ognuno dei fattori tecnici dai quali nasce l’immagine cinematografica (tanto piú se sonora) contribuisce a questa deformazione.
Gli obiettivi, p.e., sono una fondamentale fonte di deformazione. I lungofocali e i grandangolari direi che ne sono fonte addirittura intensa pressoché esplicitamente. Ma anche gli obiettivi normali lo sono. (E quanti tra coloro che usano, com’è di moda, i lungofocali – «per avvicinare», «per far vedere meglio» – nel documentario si preoccupano del fatto che deformano? Se lo fanno coscientemente, per ottenere un certo effetto, una certa espressione di quanto vogliono dire, hanno ragione di farlo; ma dove va la documentazione?) E si può fare immagine cinematografica documentaria senza obiettivi?
E il quadro, questa elementare fondamentale prerogativa dell’immagine filmica? Il quadro di per sé non deforma, isola. Il che è pure deformare, in certo senso. Credi di vedere una piazza vuota ed è il quadro che l’ha tagliata proprio al limite in cui finiva la massa di quelli che assistevano al comizio, cosicché questa rimanga esclusa. Credi di vedere una persona o una cosa vestita tutta d’oro ed è il quadro che l’ha presa solo al punto dove quell’oro cominciava: il resto che non è d’oro non lo vedi. Credi di vedere una persona nuda ed è il quadro che si ferma dove cominciano i vestiti. Credi di vedere un deserto o un mare in tempesta ed è il quadro che ti impone di non vedere il bosco attorno a quel fazzoletto di sabbia o di prendere per buona una bacinella d’acqua agitata.
E il montaggio? Con l’accostamento delle sole figurazioni, può far apparire due settori dello stesso lembo d’affresco o contigui due palazzi che stanno in due continenti diversi o legati due avvenimenti disgiunti nel tempo e nello spazio o dissiti di anni e di chilometri due momenti della stessa azione.
Come si vede, con queste semplicissime elementari preliminari constatazioni, il discorso sulla verità del documentario si fa davvero interessante. E il problema culturale e sociale del documentario stesso comincia a far apparire tutta la sua vasta profondità.
La «macchina da presa nel buco del muro o della serratura» è una felice intuizione stilistica e tematica di Zavattini, ma – sotto il profilo di teoria del linguaggio – è quasi un’assurdità.
La macchina registra, certo, quello che le sta davanti. Ma come lo registra? Basta un’angolazione, un obiettivo, un tipo di sensibilità di pellicola, una durata di registrazione diversi, per dare a quelle registrazioni – di una stessa realtà materiale, si noti! – diversissimi e anche opposti valori.
Quando poi interviene da parte del cinema il montaggio e la sonorizzazione e da parte della realtà la sua parte «dentro» anziché solo quella dei contorni, c’è da perdersi veramente.
Il buco del muro o della serratura serve solo – ed è in questa linea l’intuizione magnifica di Zavattini! – a far sí che la realtà si svolga come se non ci fossimo noi che la registriamo e a far sí che noi ci interessiamo a ciò che veramente succede nella vita e non a ciò che noi stessi facciamo succedere. Documentario, appunto. Ma il problema teorico rimane.
È chiaro dunque che la concezione di molti, secondo la quale il rapporto immagine filmica-realtà è diretto, si basa su un errore di fondo.
È chiaro dunque che il cosiddetto «cinema senza linguaggio» – quel cinema che consisterebbe nel far scattare la cinepresa dove e come capita davanti alla realtà che si vuole rappresentare, lasciando ad essa il compito di registrare quello che noi abbiamo deciso di registrare – è una sublime, commovente, idiozia.
Tutto ciò sarebbe giusto, se la macchina da presa non avesse quadruccio, obiettivi, pellicola, supporto fisso e mobile; e se non ci fossero tutte le fasi tecniche di realizzazione – dal montaggio al missaggio – che seguono la ripresa.
Sarebbe giusto ancora se l’uomo che sta dietro a quella macchina da presa e a quelle fasi non ci fosse e non si servisse del cinema per comunicare una sua esperienza.
L’uomo dunque – l’autore – è ancora una volta al centro di tutta l’operazione documentario. E da lui ne dipende – per altro condizionatamente – la verità.
E siamo cosí risospinti al nostro discorso teorico.
Se questa è la natura del cinema e se il documentario ovviamente non vi si può sottrarre, è possibile, e come, una verità del documentario stesso?
Sulla base delle constatazioni fatte é relativamente semplice ricostruire in sede teorica la strada autentica per tale verità.
Ritornano le nostre brevi divagazioni sulla realtà e sulla verità: la realtà è quella certa cosa che ha un «dentro» (la sostanza, l’entità, l’essenza) e un «fuori» (i contorni); la verità è l’adeguazione tra una mente e una realtà.
Bisogna, dunque, ci sia anzitutto una verità nella mente del documentarista nei confronti della realtà. Bisogna poi che ci sia una verità del documentario nei confronti di quella mente. Verità logica e verità ontologica, direbbero i tecnici della filosofia.
Il passaggio è obbligatorio. Non è macchinosità teorica; è concretezza di fatti e di constatazioni pratiche.
C’è una certa realtà. Essa ha contorni. Il suo significato vero e profondo è contenuto o nascosto o velato in essi. Questi contorni saranno quelli – e solo quelli – che la macchina da presa potrà registrare direttamente; ma essi dovranno essere ripresi in modo – e ciò per l’imprescindibile natura del cinema – che, nei nuovi rapporti assunti all’interno d’un quadro bidimensionale, essi restino ancora i contorni significanti di quella realtà.
Per dare il senso d’ampiezza d’un locale o d’un panorama dovrò forse spezzettarlo in tanti piccoli dettagli; per darne il senso d’angustia, dovrò forse fare immagini spaziose.
La Piazza S. Pietro si caratterizza per un colonnato disposto in quel certo modo e quel colonnato si caratterizza – oltre che per la sua disposizione circolare – per la fattura delle colonne. Io posso con una sola immagine d’opportuno dettaglio di colonna, richiamare l’intera Piazza a chi già la conosce. Ma chi non conosce la Piazza, potrà conoscere con quell’immagine solo un dettaglio di colonna. Io posso poi fare un’immagine dell’intera Piazza, in cui risalti bene la disposizione del Colonnato. Ma la conoscenza della Piazza attraverso quest’immagine si riferirà solo a quegli specifici contorni (in questo caso, la forma del colonnato) che avrò fatto rilevare.
Ma la conoscenza di Piazza S. Pietro, quella che si ha quando ci si arriva e la si considera (non diciamo poi quella che si ha dopo anni di considerazioni e di rilievi), non si può certo avere da tale immagine pur panoramica e complessiva.
Ecco dunque la necessità di creare un contesto filmico – cioè piú immagini – solo dal quale quella conoscenza può risultare integra.
E a questo punto, il problema – il famoso sipario! – presenta due nuovi aspetti: a) qual’è la vera «realtà» di Piazza S. Pietro; b) quale degli aspetti di questa complessa realtà io voglio far rilevare o perché uno solo è quello che mi interessa o perché uno solo di essi emblematizza per cosí dire tutta la realtà?
E una volta risolto tale duplice problema, non è ancora risolto tutto il problema della verità di un documentario su Piazza S. Pietro e della verità del documentario in genere.
Infatti, come è già evidente, la macchina da presa non è il solo momento in cui si attua la verità del documentario, benché sia il solo momento in cui il cinema prende contatto diretto con la realtà, a parte la registrazione sonora diretta. Ma questo contatto si riferisce ai contorni.
Del problema di rendere anche solo quei contorni s’è visto. Resta quello della realtà «dentro» e quello dell’idea che l’autore ha di quella realtà.
Qual’è la realtà di Piazza S. Pietro? La domanda impostata cosí non può avere risposta, perché la realtà di Piazza S. Pietro è la somma di tutti gli aspetti fisici, chimici, topografici, geografici, architettonici, umani, sociali, storici, nel passato, nel presente, nel futuro, nelle ore del giorno o della notte, con avvenimenti già successi o che possono succedere o che non possono succedere. Bisogna vedere quale di questi aspetti possa interessare a un certo momento o a chi per un discorso cinematografico.
Che se ci si solleva oltre gli aspetti puramente materiali o mensurabili (p.e. quante persone ci sono in Piazza S. Pietro alle ore 12 del giorno mese anno x, oppure quante persone all’anno statisticamente hanno visitato negli ultimi dieci anni quella Piazza), la cosa si fa ancora assai piú difficile per quanto concerne la verità, poiché c’è il primordiale dei problemi, quello cioè della conoscenza «vera» da parte dell’autore.
Per uno, la profonda realtà di Piazza S. Pietro può essere quella che essa – nella sua architettonicità e nella sua realtà umana e sociale statisticamente puntualizzata e psicologicamente individuata – dimostra lo spirito di carità della Chiesa e la sua imponenza o la sua attrattiva sui popoli d’ogni colore o la sua difficoltà d’accesso.
Per un altro, tale «profonda» realtà potrà essere – sempre in base a «contorni» oggettivamente riscontrabili – la non attualità o l’estrema attualità di una simile Piazza per quel regno spirituale ch’essa ospita ecc.
Insomma, ci troviamo al punto in cui, alla misurazione obbiettiva, fredda e scientifica dei contorni della realtà e alla rilevazione delle leggi naturali che immediatamente li reggono, subentra l’interpretazione della realtà stessa, la quale sarà «vera» o «parzialmente vera» o «falsa».
Non c’è posto dunque per un contatto diretto – cioè quel tipico duplice sipario – tra spettatore del film e realtà rappresentata; non è possibile cioè che il film sostituisca la conoscenza per esperienza diretta, anche se in qualche caso il film può servire assai meglio dell’esperienza diretta a conoscere in profondità la cosa rappresentata (p.e. certo cinema scientifico).
E a questo proposito converrà constatare anzitutto che, pur servendo direttamente a una certa «interpretazione» dell’autore, certi contorni sono rilevati e, nella loro immediata significazione, rappresentano e «dicono» la realtà, almeno in determinati aspetti.
Converrà constatare ancora che in molti casi quell’«interpretazione» dell’autore – o meglio, il suo contenuto mentale, espresso dalle immagini – è proprio in funzione della conoscenza adeguata della realtà documentaria. Ma in questo caso l’autore avrà dovuto fare i conti – nel senso già detto – con la natura deformante dell’immagine cinematografica.
Non è chi non veda dunque la somma e anche la delicatezza di problemi che s’affacciano non appena si voglia parlare di verità nel documentario.
Da tutto questo discorso, mi pare si possa tuttavia trarre qualche indicazione concreta.
Anzitutto è certo che ci può essere nel documentario una certa verità relativa ai contorni, qualora: a) l’autore ne abbia precisato in sé gli aspetti che vuol rilevare o quelli che sono in qualche modo emblematici; e b) sappia usare della stessa natura deformante dell’immagine per dare non deformatamente quegli aspetti.
Certo è ancora che ci può essere verità del documentario per quanto concerne l’adeguatezza delle immagini al contenuto mentale dell’autore, comunque esso sia: vale a dire, interpretazione – vera o meno vera, piú o meno profonda – della realtà presa in oggetto.
Certo è soprattutto che la verità del documentario è una delle verità piú difficili ad aversi in cinema, per la complessità tecnica del linguaggio cinematografico e per quella sua natura deformante nei confronti della cosa rappresentata e significante un contenuto mentale attraverso contorni anziché attraverso concetti. E, ciò, quando il documentario si propone proprio quale quel tipo di film che vorrebbe sostituirsi alla conoscenza per esperienza diretta della realtà rappresentata e vorrebbe prescindere da interpretazioni soggettive dell’autore delle immagini.
Dal documentario partono molti che vogliono giungere al film spettacolare e al soggetto. Ma esso dovrebbe essere piuttosto il punto d’arrivo di lunga esperienza e approfondita meditazione.
Non stupisce quindi che molti tra i migliori registi provengano dal documentario (vedi Antonioni) o anche – ed è interessante il notarlo – dal montaggio (vedi Resnais) o dal vignettismo di costume (vedi Fellini). È profondo il rapporto tra documentario e montaggio, proprio per quanto s’è detto piú sopra a proposito d’un contesto filmico necessario a superare i limiti della rappresentazione immaginaria. Il vignettismo di costume, poi, è già esso stesso, in qualche modo, documentario.
E peraltro non stupisce che piú d’uno, nel documentario, s’areni. Il documentario è un banco di prova tremendo: o si capisce o non si capisce il cinema. Chi capisce, facilmente avanza: chi non capisce, o s’arena o fallisce presto. Per strada meno maestra ma meno esposta del documentario, il neocineasta sarebbe arrivato non al cuore ma ai margini; sarebbe comunque arrivato. Col documentario o s’arriva al centro o non s’arriva. (Nazareno Taddei sj)